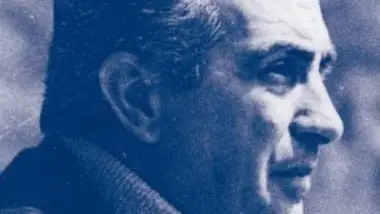Dagli archivi napoleonici alle memorie rurali, il lavoro dello storico originario di Castrovillari continua a illuminare le radici sociali e culturali di una regione spesso considerata periferica
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Sono trascorsi cinquant’anni dal giorno in cui Umberto Caldora, nato il 19 agosto 1924 a Castrovillari da Biagio, veterinario di paese, e Idea Uva, si è spento nelle residenze dell’Università della Calabria, l’istituzione che aveva contribuito a far nascere e che lo aveva appena nominato ordinario di Storia Moderna. La sua traiettoria esistenziale si inserisce in quel particolare habitus intellettuale del Mezzogiorno postbellico: un percorso che parte dal liceo locale, passa per la laurea in Lettere a Napoli e si consolida attraverso un’appartenenza generazionale segnata dal bisogno di dare voce a una regione percepita come periferia storica.
Umberto Caldora è stato un “mediatore culturale” tra archivi polverosi e comunità rurali, tra documenti ufficiali e memorie orali che ancora oggi circolano nei mercati di Cosenza o nei racconti dei pastori del Pollino. Il suo lavoro è un’etnografia del potere nel momento in cui il Regno di Napoli viene investito dalle riforme napoleoniche. In “Calabria napoleonica (1806-1815)” – 482 pagine pubblicate nel 1960 dalla Fausto Fiorentino – l’autore adotta un approccio che potremmo definire proto-antropologico, integrando i dispacci di Masséna e Murat con le relazioni dei sindaci di villaggio, le denunce di brigantaggio e le petizioni contadine. Emerge così un quadro di società stratificata dove l’introduzione del catasto è un evento che ridefinisce i confini simbolici della proprietà, generando conflitti tra notabili di città e masse rurali.
Un esempio concreto: nelle valli del Crati, la coscrizione obbligatoria francese strappa migliaia di giovani alle reti parentali, creando vuoti demografici che si riempiono con l’espansione del brigantaggio. Caldora documenta come, nel 1811, la popolazione calabrese si aggiri intorno alle 500.000 anime, concentrate in oltre 400 comuni, con un’economia basata su cereali, seta e pastorizia transumante. Le statistiche murattiane, che lui stesso trascrive e commenta in “La Calabria nel 1811”, diventano strumento per leggere le asimmetrie di genere e di classe: le donne, rimaste a gestire poderi e famiglie, sviluppano strategie di resistenza quotidiana – dal contrabbando di sale alla falsificazione di certificati di esenzione – che anticipano forme di agency femminile poi studiate dall’antropologia del Mediterraneo.
La sua morte a 51 anni interrompe un’indagine che stava estendendosi al Risorgimento come processo di “incorporazione periferica”: come la Calabria, con le sue reti di clientelismo borbonico, viene progressivamente assorbita nello Stato unitario, mantenendo però strutture di potere locali che ancora oggi influenzano la politica regionale.
A Castrovillari, il viale intitolato al suo nome è un dispositivo mnemonico che lega la memoria individuale alla continuità comunitaria, così come una importante aula dell’Unical. In un momento in cui la Calabria registra tassi di emigrazione tra i più alti d’Europa, rileggere Caldora significa interrogarsi su come le riforme dall’alto abbiano sempre interagito con le resistenze dal basso, producendo quella particolare “ibridità” sociale che caratterizza il Sud contemporaneo.
*Documentarista