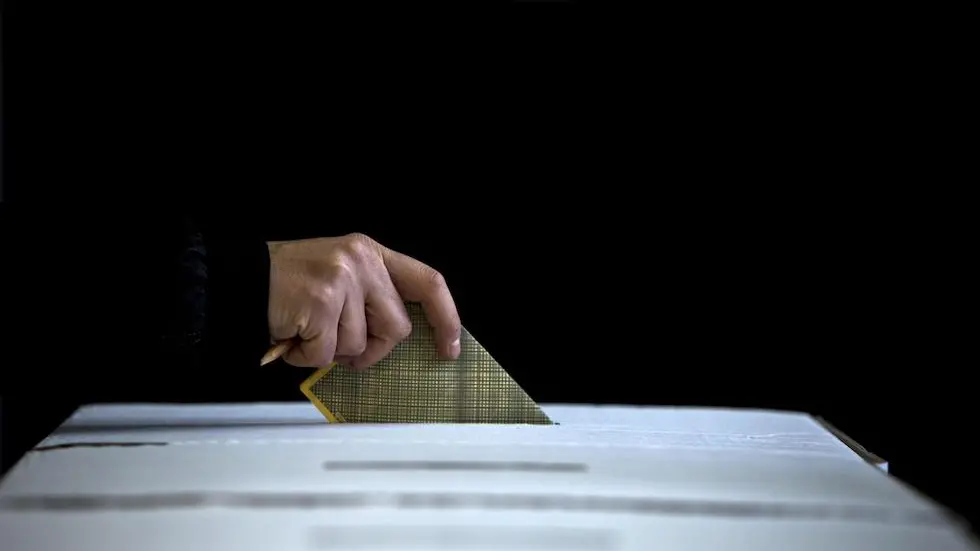Tra 2003 e 2024 la partecipazione politica si è trasformata: disaffezione crescente, indifferenza di massa e un dibattito che sopravvive solo sui social. La democrazia rischia di restare senza cittadini attivi
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Tra 2003 e 2024 la partecipazione politica si è trasformata: disaffezione crescente, indifferenza di massa e un dibattito che sopravvive solo sui social. La democrazia rischia di restare senza cittadini attivi.
C’è un’Italia che scrolla lo schermo, mette un like, magari condivide un post indignato. Poi, al momento del voto, si presenta diligente in cabina elettorale. È l’Italia descritta dal nuovo rapporto Istat sulla partecipazione politica, un documento che mette nero su bianco la parabola discendente dell’interesse civile negli ultimi vent’anni.
I dati sono inequivocabili: meno di un italiano su due (48,2%) si informa almeno una volta a settimana di politica. Un calo di quasi nove punti percentuali rispetto al 2003. E non basta: quasi un terzo della popolazione (29,4%) dichiara di non occuparsene mai. Quindici milioni di persone vivono come se le decisioni prese nei palazzi del potere non avessero nulla a che vedere con la loro vita quotidiana.
La fotografia sociale è impietosa. A determinare il grado di partecipazione è ancora una volta il titolo di studio. L’11,3% dei laureati si tiene lontano dalla politica, ma la percentuale sale al 24,4% tra i diplomati e supera il 41% tra chi possiede solo la licenza media. Non è un dettaglio: significa che la democrazia si alimenta sempre meno dei ceti popolari e rischia di trasformarsi in un gioco per chi ha strumenti culturali maggiori.
Il divario di genere, che vent’anni fa vedeva le donne molto meno partecipi degli uomini, oggi si è ridotto. Ma non perché le donne abbiano recuperato terreno: sono gli uomini ad aver perso entusiasmo. Se nel 2003 il 66,7% si informava con regolarità, oggi lo fa il 54,1%. Le donne sono passate dal 48,2 al 42,5%. Insomma, si avvicinano, ma verso il basso, in un deserto di indifferenza.
A pesare, come sempre, è anche la geografia. Al Nord e nel Centro la maggioranza si informa almeno una volta a settimana, con valori sopra il 50%. Nel Mezzogiorno, invece, la percentuale scende al 40%. Qui più di un terzo degli abitanti ammette di non interessarsi mai alla politica. Un dato che fotografa non solo l’apatia, ma anche il distacco da istituzioni percepite come lontane.
Poi c’è il capitolo media, quello più clamoroso. I talk show politici, un tempo regine della prima serata, hanno perso appeal. Se nel 2003 oltre il 21% degli italiani li aveva seguiti almeno una volta nell’anno, nel 2024 la quota è crollata al 10,8%. Stessa sorte per i quotidiani cartacei: dal 50,3% di lettori siamo scesi al 25,4%. In pratica, solo uno su quattro compra ancora il giornale. Una débâcle che rende il terreno ancora più scivoloso.
A tenere banco sono i social network. Quasi la metà degli utenti Internet (47,5%) si informa di politica attraverso Facebook, Instagram, TikTok o X. Eppure, tra i frequentatori della rete, il 65,4% continua a leggere le versioni online dei quotidiani. È il segno che la carta muore, ma non la necessità di un’informazione autorevole. Il problema è che in mezzo si inseriscono algoritmi e fake news, capaci di orientare umori e voti in modo più rapido di qualunque campagna elettorale tradizionale.
Il dato forse più inquietante, però, riguarda la parola: il 36,9% degli italiani non parla mai di politica. Più di 19 milioni di persone hanno smesso di discuterne con amici, familiari o colleghi. In silenzio, il dibattito pubblico evapora. Restano minoranze rumorose, spesso aggressive, che monopolizzano il discorso.
Eppure, nonostante questo scenario di disaffezione, quando arriva il momento del voto l’Italia si muove. Le file ai seggi non mancano, la ritualità del gesto resiste. È come se la politica fosse fastidiosa per 364 giorni l’anno, ma diventasse improvvisamente obbligatoria quando si deve barrare una scheda. Un cortocircuito che rivela la fragilità del sistema: partecipiamo senza sapere, votiamo senza discutere, deleghiamo senza controllare.
Per gli studiosi dell’Istat, la questione è seria: «La qualità della democrazia dipende dalla natura del rapporto tra cittadini e istituzioni. Se cala l’informazione e si indebolisce il dialogo, cala anche la coesione sociale». Tradotto: senza cittadini consapevoli, la democrazia è un guscio vuoto.
Il futuro, a guardare i dati, non promette scosse positive. Le nuove generazioni, pur più abituate a muoversi online, non sembrano più interessate a un dibattito politico tradizionale. Preferiscono forme di partecipazione lampo: un hashtag, un corteo, un video virale. Tutto brucia e tutto svanisce con la stessa rapidità.
Il rischio è quello di abituarsi a una democrazia “a bassa intensità”: la gente vota, ma non discute; si indigna, ma non studia; si mobilita, ma solo per un giorno. E intanto cresce l’idea che altri sistemi, più veloci e autoritari, siano più efficienti. Una suggestione pericolosa che i numeri Istat non fanno che confermare.