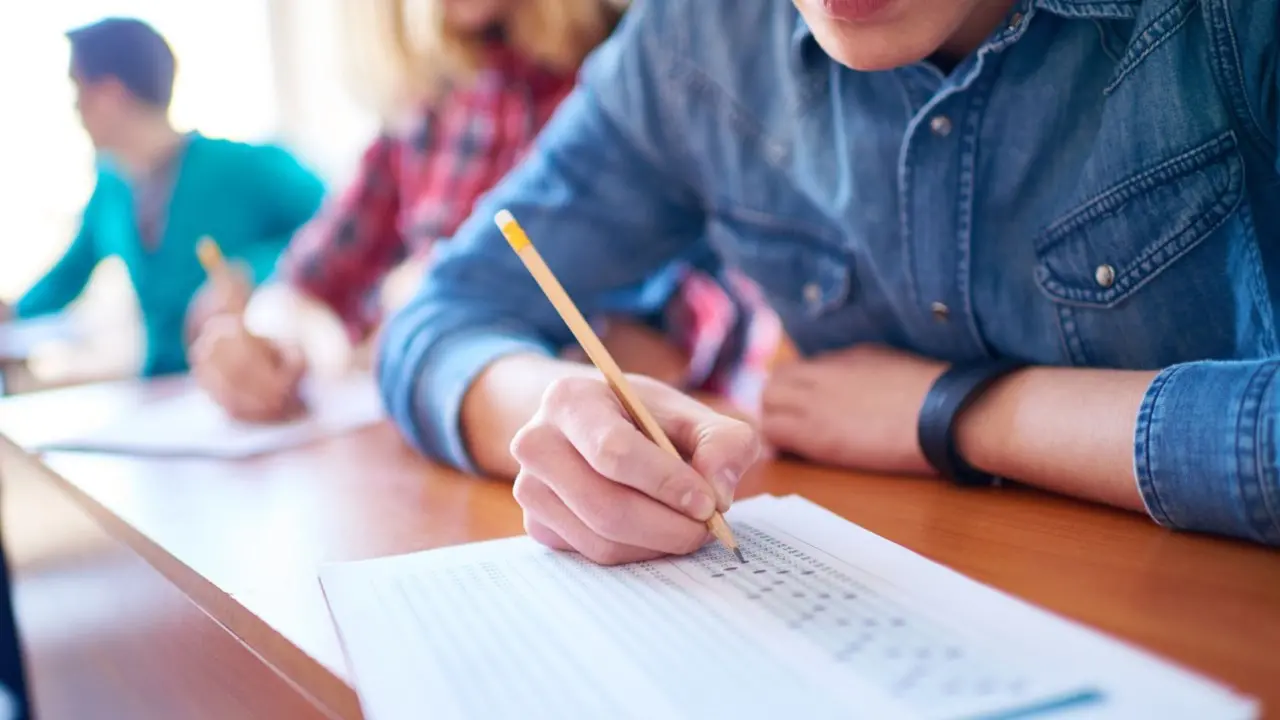La riforma è solo un insieme di ritocchi che toccano la superficie ma non le radici. Si continua a inseguire l’emergenza e il simbolo, senza affrontare le questioni strutturali
Tutti gli articoli di Opinioni
PHOTO
Questa nuova/vecchia direzione sembra dettata più dal bisogno di risparmiare qualche spicciolo che da una vera visione politica. Non c’è un progetto educativo dietro, ma un’operazione di contenimento: meno commissari, meno spese, più slogan. Una riforma costruita attorno all’ossessione di evitare la “scena muta”, quella protesta silenziosa che alcuni studenti avevano scelto come gesto di rifiuto, e che ora diventa il pretesto per introdurre la bocciatura automatica.
La scuola – lo dice la legge, non la retorica – non dovrebbe infliggere sanzioni punitive, ma solo sanzioni educative. Lo stabilisce chiaramente lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, art. 4, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235): ogni misura disciplinare deve avere “finalità educativa” e deve sempre rispettare la dignità della persona. Qui invece siamo davanti a una norma che non educa ma reprime, che non apre spazi di confronto ma li chiude con la serratura della bocciatura.
La scuola che oggi si racconta come “moderna e inclusiva” elimina il dissenso con un colpo di spugna: non insegna più a trasformare la protesta in dialogo, non mostra ai ragazzi i limiti di un gesto sterile come la scena muta. Semplicemente la cancella. È un bavaglio istituzionale che, con la scusa di garantire serietà all’esame, in realtà addestra all’obbedienza.
Intanto i veri problemi restano fuori dall’aula. Nessuna riforma affronta la frattura tra Nord e Sud, evidente in ogni ambito, perfino nei trasporti che portano i ragazzi a scuola. Nessun intervento serio sulle classi sovraffollate, sugli stipendi dei docenti che restano tra i più bassi d’Europa e sulla precarietà diffusissima. Si interviene solo sull’esame finale, quasi fosse il simbolo da esibire al Paese per dire che “qualcosa si è fatto”.
Dal 2026 tornerà il nome storico: “esame di maturità”. Una parola che richiama gli anni ’60, i banchi di legno, i genitori che aspettavano fuori con le sigarette accese e il fiato sospeso. Un revival rassicurante, che piace ai nostalgici e ai politici in cerca di facili consensi. Ma dietro al lessico non c’è il ritorno a un ideale, c’è l’ennesima oscillazione di un sistema che cambia regole a ogni legislatura: la seconda prova, il colloquio che da multidisciplinare diventa limitato a quattro materie decise ogni anno dal ministero, l’alternanza che si trasforma in percorsi scuola-lavoro, le commissioni che da sette passano a quattro con due commissari esterni e due interni, più un presidente di commissione.
Si cambiano le date, con la prima prova di italiano che non sarà più di mercoledì ma di giovedì, e la seconda che seguirà il giorno dopo. Si introduce un piccolo bonus di tre punti in più per chi arriva almeno a novantasette centesimi, ma non per gli altri. Si stabilisce che la condotta diventi decisiva: chi non raggiunge il sei non sarà nemmeno ammesso, chi si ferma al minimo dovrà presentare una tesina di cittadinanza, chi raggiunge il nove otterrà il massimo dei crediti. Si cambia persino il nome dei PCTO, che tornano a essere “percorsi di formazione scuola-lavoro”, mentre i risultati delle prove Invalsi non compaiono più subito, ma solo a fine percorso, in forma descrittiva.
È un insieme di ritocchi che toccano la superficie, ma non le radici. Una riforma che continua a inseguire l’emergenza e il simbolo, senza affrontare le questioni strutturali.
Se i presidi dell’ANP hanno applaudito, definendo la riforma «in linea con il percorso formativo degli ultimi anni», ben altra è la reazione degli studenti. L’Unione degli Studenti ha parlato di «modello repressivo» e ha annunciato mobilitazioni. «Il ministro si riempie la bocca di educazione civica, ma nella pratica spazi di discussione e partecipazione vengono repressi, non ascoltati», ha dichiarato Federica Corcione, dell’esecutivo nazionale.
Molti docenti sottolineano un paradosso: da un lato si annuncia formazione per i commissari e qualche aumento nei compensi, dall’altro si riduce il numero degli esterni, segno che l’obiettivo primario resta il risparmio. E allora la domanda si impone: se la riforma nasce per «potenziare la funzione formativa e orientativa dell’esame», perché non partire dalle disuguaglianze territoriali?
Mentre in Italia si discute sulla scena muta, in Europa i modelli si muovono in tutt’altra direzione. In Finlandia non esiste un esame nazionale di fine ciclo, ma una valutazione continua e personalizzata che mette al centro la fiducia negli insegnanti. In Francia il Baccalauréat resta, ma è stato riformato in senso modulare, con maggior peso alle materie scelte dallo studente. In Germania l’Abitur varia da Land a Land, ma mantiene un equilibrio tra prove scritte e orali, senza mai trasformare il silenzio in un’arma repressiva. Nel Regno Unito gli A-Levels sono severi, ma flessibili e strettamente legati all’accesso universitario.
L’Italia, invece, sembra voler ribadire un principio punitivo: chi tace non matura.
Io mi chiedo: che senso ha una scuola che insegna a recitare, ma non a dissentire? Una scuola che preferisce zittire un gesto di ribellione piuttosto che trasformarlo in occasione di crescita?
Educare viene da ex-ducere, “tirare fuori”. Qui invece stiamo spingendo dentro: dentro un imbuto, dentro un copione, dentro una griglia di valutazione che misura tutto, tranne ciò che conta davvero.
E allora la maturità rischia di non essere più la soglia verso l’età adulta, ma solo un vuoto rituale amministrativo. Non l’inizio di una responsabilità, ma la fine di un percorso che non ha insegnato ai ragazzi a prendersi la parola, ma solo a temere il silenzio.
La scuola, se perde la capacità di educare al dissenso, perde se stessa. E con essa perdiamo tutti: un Paese che ha paura delle domande non sarà mai un Paese maturo.