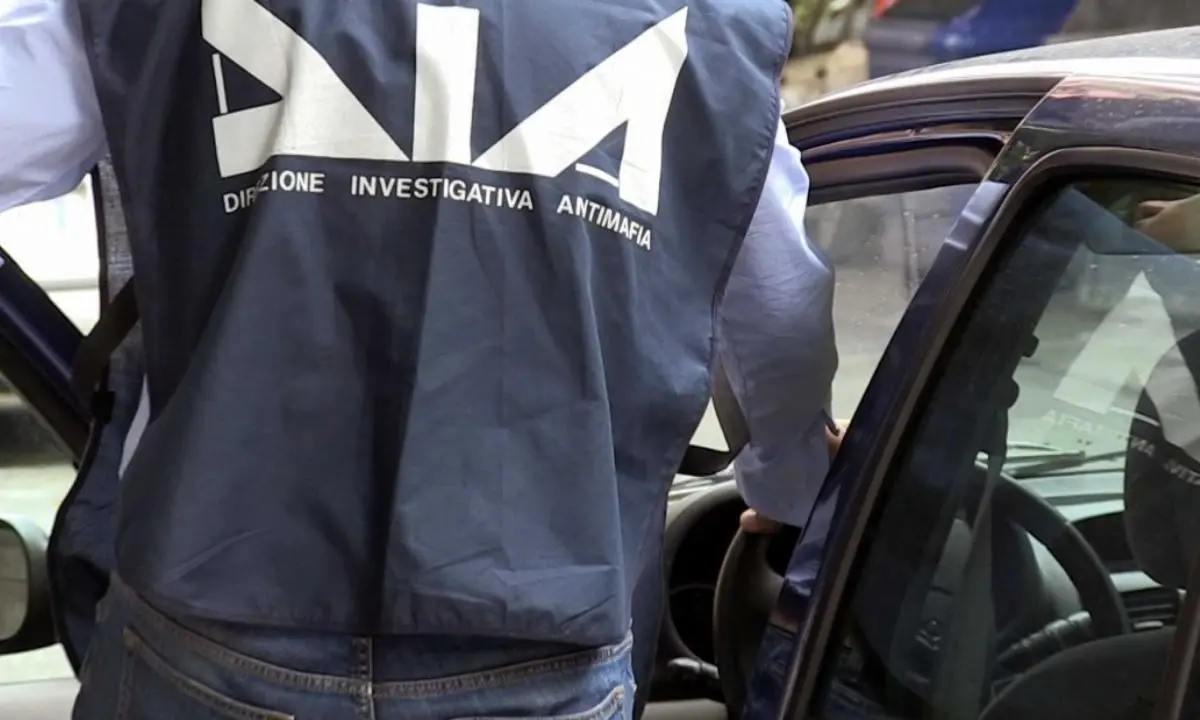Le mafie non si limitano più a controllare territori con la violenza: ora gestiscono lavori pubblici, investimenti del Pnrr e criptovalute. Corruzione e area grigia alimentano un sistema che soffoca la crescita sana dell’economia
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
HUAI'AN, CHINA - DECEMBER 5, 2024 - A bitcoin model is seen in a shopping cart in Huai 'an city, Jiangsu province, China, December 5, 2024. (Photo by CFOTO/Sipa USA)
Inizia oggi una serie di approfondimenti sul nuovo metodo mafioso affidati alla studiosa Francesca Levato.
Con questa riflessione intendo chiarire, per quanto l’esperienza mi ha insegnato, le alterazioni di un sistema che ad oggi governa, per la maggiore gli appalti pubblici. Non mi arrogo la capacità di trovare delle soluzioni a questo fenomeno criminoso ma cercherò di fissare qualche punto di certezza, da cui partire per riconoscere la sintomatologia del malaffare. Un esempio rivelatore, risalente nel tempo ma indicativo già da allora, da cui partire per capire la relazione tra mafia ed appalti è il “Sacco di Palermo” (1958-1963), durante il quale la mafia siciliana ottenne oltre 3.000 licenze edilizie su 4.000 rilasciate dal comune di Palermo.
La penetrazione delle mafie nell’economia nazionale
Attualmente, dalle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, dalle sentenze della magistratura penale, dagli studi di esimi analisti e cultori della materia emerge che la penetrazione delle organizzazioni criminali nell’economia nazionale ha raggiunto livelli senza precedenti, con effetti negativi come l’effettivo mascheramento delle attività criminali e un sempre maggiore controllo del territorio nelle regioni coinvolte con una proiezione in ambito internazionale e intercontinentale per alcuni affari.
Quattro macrocategorie di infiltrazione
Quattro sono le macrocategorie che la magistratura ci restituisce quando giudica e si pronuncia su affari malavitosi:
- Reati legati a mafia (intesa come fenomeno nel senso ampio delle sue diverse articolazioni, parliamo di ‘ndrangheta, di camorra, di mafia siciliana, di sacra corona unita) in relazione alla corruzione della PA ed all’uso della nuova moneta corrente cd bitcoin;
- Rischio di prestanome e di insinuazione negli appalti tramite istituti giuslavoristici di esternalizzazione (distacchi di manodopera, contratti di rete, noli a caldo);
- Rischio di network, utilizzo patologico dei social tramite il dark web;
- Trasparenza, assenza di trasparenza nelle fasi di aggiudicazione degli appalti.
Indicatori diretti e indiretti di controllo mafioso
Ci sono quindi degli indicatori diretti che rivelano se le imprese sono controllate (direttamente o indirettamente) da criminali coinvolti in attività mafiose e/o corruzione: per esempio la chiara traccia di gestione familistica diretta delle società da parte di famiglie, ‘ndrine, cosche, clan. Naturalmente nel tempo, le mafie hanno sviluppato altre strategie più sofisticate per “ripulire” l’immagine delle imprese che controllano: si tratta di scatole cinesi la cui solo analisi storica di derivazione riconduce al boss. Esistono pur sempre i mandamenti e i distretti. In particolare, le organizzazioni criminali stanno diventando sempre più abili nel manipolare fondi pubblici e infiltrarsi in imprese legali per ottenere licenze per lavori pubblici ed accedere a fondi pubblici di importi elevatissimi con il risultato di avere fatturati esorbitanti.
Investimenti pubblici, PNRR e fondi sotto attacco mafioso
Gli investimenti pubblici, i fondi Pnrr, i Fondi Giubileo, i superbonus etc che dovrebbero aiutare la popolazione locale a emanciparsi dal giogo mafioso finiscono per arricchire ulteriormente i mafiosi stessi, che sono ormai in grado di fare incetta di appalti pubblici. In passato le organizzazioni malavitose deprimevano l’economia di un territorio, riducendo quindi la capacità di spesa pubblica locale, adesso le organizzazioni criminali hanno le competenze per poter attrarre più investimenti pubblici nelle loro zone di influenza e di interesse (perché non è scontata la zona in cui investire), in modo da vincere facilmente un maggior numero di appalti. Certo sintomatico oggi, come la cronaca quotidiana riporta, è l’indice di corruzione della PA. Di complicata attività si parla quando gli affari si concludono tramite l’uso dei bitcoin. Tra gli indicatori indiretti che si definiscono come indici sintomatici di anomalia, si possono includere diverse misure del rischio di prestanome, ovvero il rischio che le organizzazioni criminali assumano persone senza precedenti penali per gestire le loro attività economiche ed il cui collegamento con “il capobastone” è difficile da rintracciare per gli investigatori. Nonostante gli sforzi del governo italiano nel 2011 con l’introduzione della Banca dati nazionale unica, della documentazione antimafia e dell’autocertificazione antimafia, questi strumenti presentano limiti, come la richiesta di certificati solo in casi specifici e la possibilità per le mafie di aggirare questi controlli ricorrendo a dei prestanome. Successivamente, esamineremo un insieme di variabili che catturano il grado di connessione di un’impresa con l’economia criminale (legale o illegale) anche tramite l’uso dei social o, meglio, del dark web. Infine, si rende sempre più auspicabile scoprire ed individuare un criterio sempre più attuabile per valutare la trasparenza delle imprese, ossia il grado di divulgazione delle informazioni sopra menzionate.
La corruzione nella Pubblica amministrazione
Sul versante del contrasto alla corruzione, è compito di ogni Paese costruire una strategia di ampio respiro, che integri la promozione dell’integrità pubblica con il contrasto e la prevenzione della corruzione. Non si tratta solo di far emergere le dinamiche corruttive, ma di costruire e mantenere meccanismi che possano ridurre il fenomeno. Bisogna abbandonare l’approccio legato all’anticorruzione come pratica per far emergere i fenomeni penalmente rilevanti e scegliere, per il futuro, la promozione della cultura dell’integrità dei processi decisionali pubblici. Ma purtroppo ad oggi la cronaca rimbalza di casi eclatanti di malaffare architettato e sostenuto grazie alle posizioni di funzionari e dirigenti pubblici. La continua canalizzazione tra politica, PA e malaffare non consente alla collettività perbene di emanciparsi e notizie quali quelle, ultime in termini temporali, dello scandalo Milano dell’Urbanistica sono demoralizzanti a fronte del sistema «gravemente corruttivo» che è stato messo in atto. Ma quale è il vero motivo di tale asservimento della PA alla corruzione? Alla memoria soccorrono subito gli Artt. 97-98 della Costituzione: il buon andamento della Pubblica Amministrazione al servizio della Nazione e la lotta alla corruzione. a corruzione è una deviazione dal bene comune, su cui prevale l’interesse privato. L’interesse pubblico è il fine ultimo dell’azione della Pubblica Amministrazione (P.A.). Il fenomeno corruttivo, infatti, discende da un malfunzionamento della macchina amministrativa, da una violazione dei doveri legati all’esercizio della funzione pubblica, dalla lesione dell’interesse collettivo. Ne consegue l’uso improprio e dispendioso delle risorse pubbliche, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione e la perdita della sua credibilità. La corruzione, spesso alimentata da pressione fiscale, burocrazia eccessiva e disoccupazione, indebolisce le istituzioni e crea un terreno fertile per le attività mafiose.
Il metodo mafioso e l’area grigia
Le organizzazioni criminali, a loro volta, sfruttano la corruzione per infiltrarsi nella pubblica amministrazione e controllare settori chiave dell'economia ed ecco che si delinea il “metodo mafioso” e la sua alleanza con la PA. In questo contesto di profonde trasformazioni della criminalità organizzata, si registra una celere evoluzione del “metodo mafioso”: c’è un minore ricorso alla violenza, esercitata o minacciata (ad eccezione ancora della camorra napoletana) per favorire invece relazioni di scambio e collusioni nei mercati legali, utilizzando “la disponibilità degli imprenditori e dei funzionari pubblici ad entrare in relazioni con i mafiosi pur sapendo con chi hanno a che fare, sulla base di semplici valutazione di convenienza” e di competitività delle loro aziende. Emblematico poi in tal senso è il reinvestimento dei proventi illeciti nell’economia pubblica, dove le mafie prediligono il ricorso sistematico alla corruzione per facilitare l’infiltrazione negli appalti e nei sub-appalti: il denaro deve circolare e va reimmesso nel mercato al più presto possibile per essere ripulito ed essere reinvestito in altri disdicevoli affari (di particolare attenzione all’uopo si rammenta la crescita della grande distribuzione per esempio). Le organizzazioni dedicano perciò una particolare attenzione alla “promozione di relazioni di collusione e complicità con attori della cosiddetta “area grigia” (imprenditori, professionisti, politici, pubblici funzionari e altri)”, definita anche come “borghesia mafiosa, composta da personaggi insospettabili i quali, sebbene non inseriti nella struttura criminale, avvalendosi di specifiche competenze professionali avvantaggiano l’associazione mafiosa fiancheggiandola e favorendola, non solo nella protezione dei propri membri, nell’allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile, ma anche nel rafforzamento del potere economico”. Rilevanti sono le figure degli intermediari professionisti nei vari settori topici: nelle banche, nell’alta finanza, nelle professioni.
La capacità di condizionare gli enti locali
Negli appalti pubblici le mafie ricercano un “accesso privilegiato alle risorse pubbliche tramite pressioni e accordi con le pubbliche amministrazioni, facendo largamente ricorso alla corruzione e offrendosi a un tempo come garanti delle transazioni che prendono forma nei circuiti di “corruzione sistemica”: in quest’ottica assume un rilievo essenziale la capacità di condizionare gli indirizzi degli enti locali come si evince dallo scioglimento delle numerose amministrazioni comunali ed i vari commissariamenti (il primo comune ad essere sciolto per mafia - anche se allora non esisteva alcuna legge in tal senso - fu Limbadi in Calabria da parte dell’allora presidente della repubblica Sandro Pertini nel 1983 per la presenza nel consiglio di un noto “capobastuni” locale). E se prima del 1992 corruzione e mafie si intrecciano da sempre al Sud, da quella data aumentano progressivamente anche al centro-nord i casi di coinvolgimento delle mafie o di violenti nella rete corruttiva, fino a diventare prassi abituale ed estendendo l’ambito di applicazione anche a livello ultranazionale ed intercontinentale (la ‘ndrangheta è considerata tra le più pericolose organizzazioni criminali del mondo con un fatturato di circa 56 miliardi di euro e con numerose articolazioni nel mondo). Tali reati risultano di difficile individuazione in ragione del meccanismo stesso della corruzione, dove entrambi i soggetti coinvolti hanno un vantaggio reciproco e quindi anche il comune interesse a tenere segrete le forme di transazione e di esazione che li coinvolge.
Le misure di contrasto necessarie
Ma quali sono le possibili misure di contrasto? Sarebbe necessario apprestare un’ampia gamma di interventi sul piano della repressione, prevenzione e rafforzamento della trasparenza, perfezionando le misure adottate quali nuove discipline su appalti, riciclaggio e autoriciclaggio, falso in bilancio, reati di corruzione, scambio elettorale politico-mafioso, controllo giudiziario delle aziende per esempio e potenziando ulteriormente l’attività degli organismi di controllo. Sarebbe auspicabile sviluppare metodi per spezzare l’omertà e l’alleanza con l”area grigia”, recidendo i rapporti di complicità, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione degli ordini professionali e delle imprese affinché sviluppino al loro interno adeguati anticorpi ed evitino così il rischio di essere coinvolti in fatti di mafia o in schemi di riciclaggio di proventi Illeciti. Le degenerazioni permanenti della politica e dell’economia (clientela, corruzione e opacità dei mercati) vanno combattute se si vogliono combattere le mafie. Sarebbe necessario procedere ad una rivisitazione del sistema retributivo degli impiegati della PA, in quanto alla base della corruzione è sempre il continuo bisogno di denaro ed un funzionario ben retribuito non necessita di abbassarsi a transare con chi propone il malaffare. Il codice penale all’art 318 disciplina la fattispecie, rubricata come “corruzione per l’esercizio della funzione”, intesa come “compravendita della funzione”, non connessa causalmente al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanza che rileva e viene disciplinata dall’art 319 del c.p. E ‘necessario prevenire la compravendita degli atti d’ufficio e garantire al contempo il corretto funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, va compreso e distrutto il nesso strumentale tra la dazione-promessa e il compimento di un determinato o comunque ben determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio e per fare ciò è necessaria maggiore informazione e formazione del pubblico dipendente, che va reso più forte anche a livello economico per respingere aggressioni o potenziali pericoli corruttivi.
L’uso dei Bitcoin e le criptovalute, il nuovo fronte delle mafie
In particolare, la ‘ndrangheta fa incetta di bitcoin per ripulire il denaro sporco. Quando si parla di Bitcoin si richiamano alla mente principi ideologici ispirati al libero mercato e al libertarismo. La struttura di tale moneta decentralizzata elimina la necessità di intermediari come banche e governi, offrendo agli utenti un controllo completo sulla propria ricchezza. Bitcoin è denaro di proprietà esclusiva dell'individuo (al portatore), senza la possibilità di confisca o svalutazione da parte di entità centrali. In questo sistema, ogni utente è responsabile delle proprie transazioni, agendo come un'entità autonoma all'interno di una rete globale. Questo modello ha attratto sostenitori (tra cui in primis le organizzazioni criminali) che vedono in Bitcoin una forma di libertà economica e un potenziale strumento per contrastare le crisi finanziarie tradizionali e aumentare il fatturato sfuggendo ad ogni controllo. L’adozione di Bitcoin come metodo di pagamento alternativo offre una serie di vantaggi, principalmente legati all'assenza di commissioni bancarie o di pagamento tipiche dei sistemi tradizionali. Bitcoin permette transazioni dirette tra il compratore e il venditore senza la necessità di intermediari finanziari come banche o piattaforme di pagamento, riducendo così i costi di transazione e aumentandone l'efficienza complessiva.
Bitcoin: transazioni rapide e globali
Le transazioni in Bitcoin sono globali e consentono, in particolare agli esercenti, di accettare pagamenti da clienti in qualsiasi parte del mondo senza incorrere in costi aggiuntivi per il cambio valuta o tempi morti per l'elaborazione di pagamenti internazionali. Le transazioni, che avvengono tramite il network decentralizzato della blockchain, sono anche rapide (a volte più veloci rispetto alle transazioni bancarie tradizionali) e immutabili, riducendo i rischi di frode o chargeback. In sintesi, Bitcoin fornisce agli esercenti maggiore autonomia economica, eliminando il controllo centralizzato da parte delle banche, governi e istituzioni finanziarie tradizionali e riducendo i costi operativi.
Criptofonini e monete virtuali
Le mafie del nuovo millennio abbracciano l’innovazione digitale e cercano di sfruttare con ogni mezzo il cyberspazio per condurre le loro attività illecite. In alcuni casi, assumono anche hacker e ingegneri informatici. Tutte le organizzazioni criminali oggi fanno uso di criptofonia. Si tratta di telefoni simili a quelli degli anni ‘90, che non hanno connessione a internet, fotocamere o geolocalizzazione, ma che sfruttano sistemi di doppia cifratura che consentono una comunicazione sicura. Ci sono organizzazioni criminali che hanno assunto hacker proprio per entrare nel cuore dell’innovazione tecnologica, ma anche ingegneri informatici per estrarre criptovalute, aggiungerle alla blockchain e investirle su piattaforme clandestine di trading.
Il crescente interesse delle mafie dopo l’annuncio di Trump
L’interesse delle mafie verso le monete virtuali, inoltre, è cresciuto da quando il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’introduzione della sua criptovaluta, proclamandosi ‘primo criptopresidente’. Prima la mafia vedeva i bitcoin con un po’ di sospetto a causa dell’andamento fluttuante del loro valore. Ma questo nuovo atteggiamento contribuirà a far crescere l’attenzione verso questo tipo di moneta. C’è un divario tecnologico nei nostri sistemi istituzionali e le mafie, le nostre polizie si stanno attrezzando e si stanno dotando adesso di bravi ingegneri informatici, ma ancora non siamo totalmente capaci e veloci quanto le organizzazioni criminali: siamo un po’ indietro, anche perché abbiamo una normativa che prevede soltanto l’impiego della cybersicurezza nell’ambito difensivo e non in quello offensivo, come hanno fatto invece i belgi, gli olandesi e i francesi. Si tratta di retaggi culturali (come si fa a reclutare un Hacker in una PA?) e di sperequazione salariale (quanto costa pagare un Hacker nella PA?). All’uopo si rammenta il caso dell’inchiesta della Procura di Milano sui dossieraggi laddove l’importanza strategica di avere un Hacker nel sistema istituzionale è balzato all’attenzione, in quanto sono stati violati decine di server di personaggi pubblici famosi e politici. E’ stato attaccato e paralizzato il sistema ed il ministro della Giustizia, Nordio risponde così: “Adeguare leggi e tecnologie. Credo che il governo debba prendere una direzione normativa e una tecnologica: adeguare le leggi, prevedendo quali possano essere le prossime mosse degli hacker e dei malintenzionati e, dal punto di vista tecnologico, proteggere nel modo migliore i dati sensibili delle istituzioni e dei privati". Le associazioni per delinquere godono sempre “di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa ” e gli indagati “spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi”. I gruppi criminali hanno una consolidata struttura “a grappolo”: ogni “componente” e “collaboratore” ha a sua volta “contatti nelle forze dell'ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni” con cui “reperire illecitamente dati”, hanno tecnologie avanzate e sono avanti anni luce rispetto alle nostre polizie , che per anni hanno fatto da apripista per le polizie internazionali ma che oggi hanno scarsi strumenti per poter competere con un “mostro” criminale cosi prolifico e ricco. (Fine prima parte. Continua)
*Ispettorato nazionale del lavoro