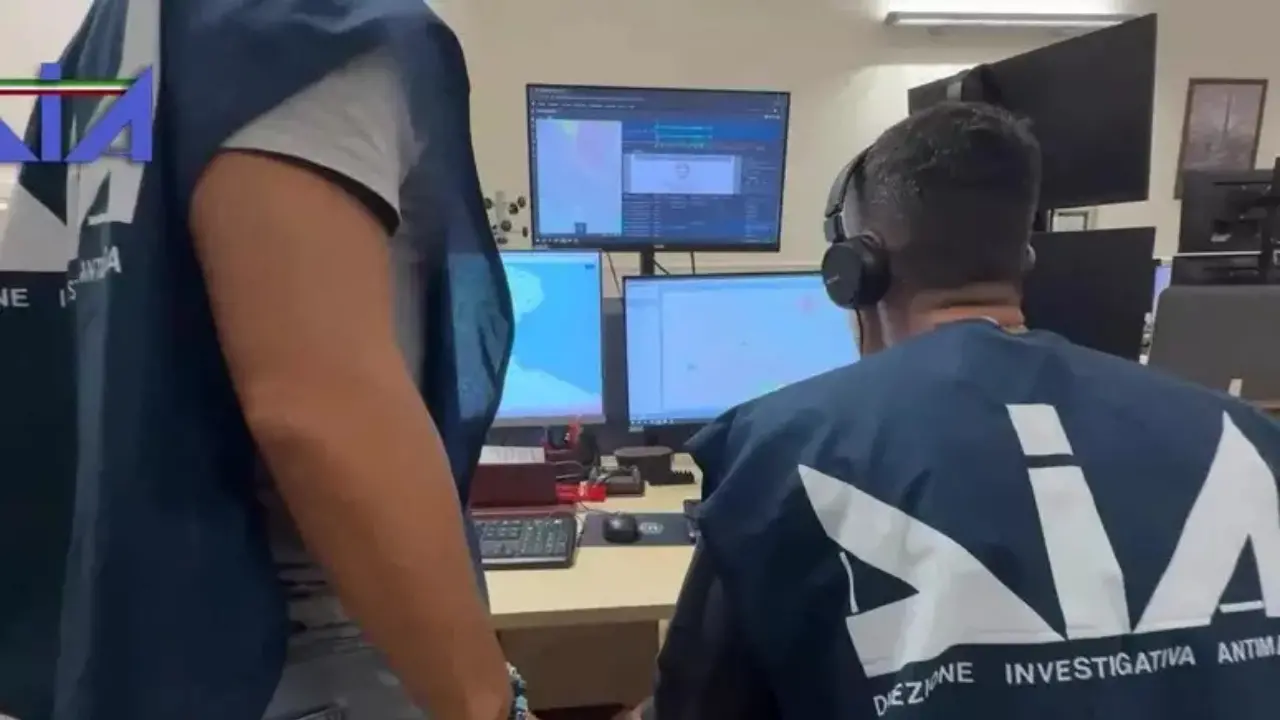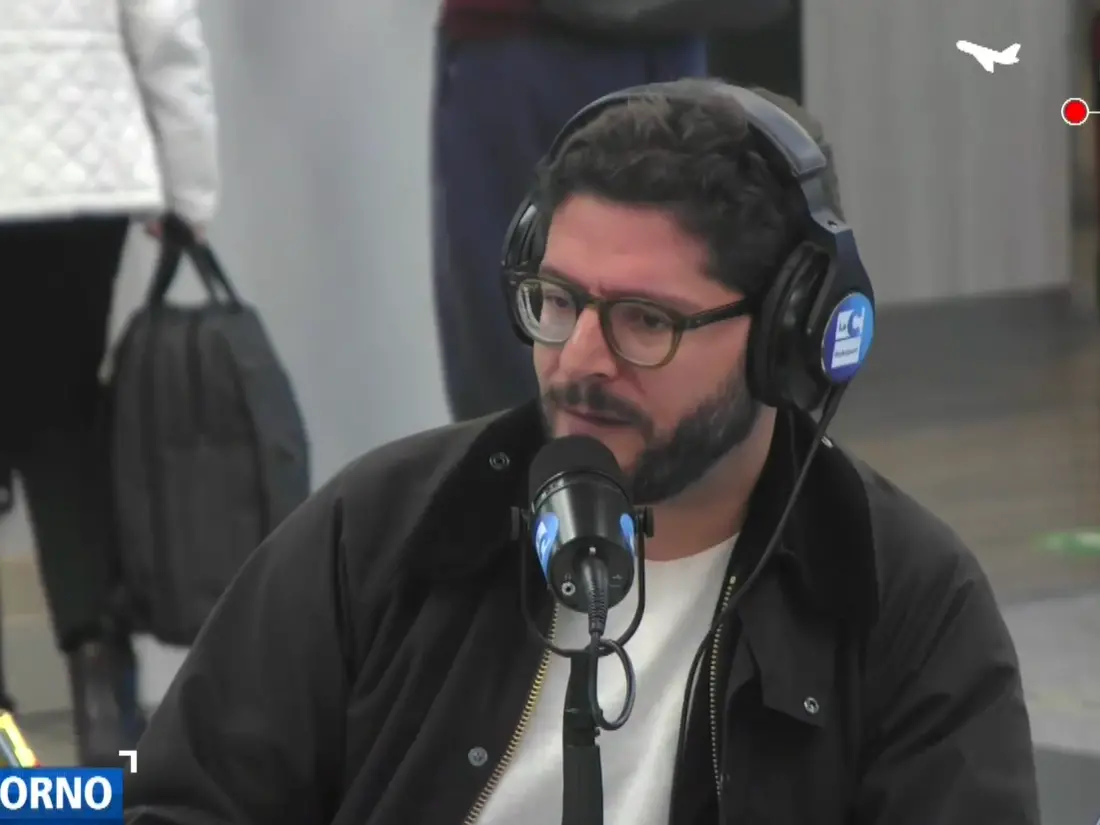Per il sondaggio Demos-Libera, i clan inquietano ma non scuotono più. Le cosche calabresi fanno paura al 26% del campione, camorra in crescita. L’84% dei cittadini punta sulla confisca dei beni ma la considera troppo costosa per lo Stato. E la rassegnazione si fa strada
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La mafia continua a essere percepita come un fenomeno onnipresente, radicato e pericoloso. Non solo nel Sud, dove storicamente ha trovato terreno fertile, ma in tutto il Paese. È un’inquietudine che accomuna gli italiani da Nord a Sud, secondo l’indagine condotta da Demos in collaborazione con Libera e anticipata questa mattina da Repubblica. Oltre nove italiani su dieci ritengono che la mafia rappresenti un problema diffuso a livello nazionale, un male che attraversa i confini regionali e sociali senza distinzione.
Tuttavia, quando la percezione si sposta dal piano generale a quello locale, le differenze emergono con maggiore chiarezza. È nel momento in cui gli intervistati sono invitati a “guardarsi intorno”, a valutare la situazione nella propria area di residenza, che la mappa della paura si trasforma. Le preoccupazioni maggiori si concentrano nelle aree geograficamente “opposte”: il Mezzogiorno, in particolare Sicilia e Campania, e il Nord-Ovest, con Piemonte e Lombardia. Due estremi che condividono una simile percezione di vulnerabilità.
Nelle regioni del Centro e del Nord-Est, invece, il fenomeno appare più distante. Non assente, ma meno percepito come minaccia quotidiana. La stessa tendenza si ripete quando si analizzano le risposte riferite ai singoli comuni: la percezione di presenza mafiosa diminuisce, pur restando più alta lungo l’asse metropolitano Milano-Torino e nelle città del Sud.
Dalle “mafie” alla “mafia”: continuità e mutamenti nella paura collettiva
Quando si passa dal concetto generale di “mafia” alle “mafie”, ossia alle organizzazioni criminali concrete e localizzabili, emergono sfumature più precise. In questo passaggio, la percezione cambia di tono, ma non di intensità. Gli italiani continuano a riconoscere la pericolosità delle organizzazioni mafiose tradizionali, anche se la gerarchia della paura mostra segnali di mutamento.
La ‘ndrangheta calabrese si conferma la più temuta: è indicata come “la mafia più pericolosa” dal 26% del campione, confermando la sua immagine di potenza economica e invisibile, capace di infiltrarsi silenziosamente nei circuiti legali. Subito dopo si colloca la camorra napoletana, segnalata dal 20% degli intervistati, in crescita significativa negli ultimi due anni. Cosa nostra, la storica mafia siciliana, mantiene invece un livello di preoccupazione del 12%, in leggero calo, ma sostanzialmente stabile rispetto al passato.
Il quadro cambia quando si guarda oltre i confini nazionali. Le “mafie straniere” destano timori più contenuti, anche se alcune tendenze meritano attenzione: cala la preoccupazione verso le “bande cinesi”, mentre cresce quella nei confronti della “mafia nigeriana”. Segno che l’attenzione dei cittadini segue l’evoluzione dei flussi criminali, adattandosi ai nuovi scenari della globalizzazione del crimine.
Le risposte dello Stato e il dilemma dei costi
Il sondaggio Demos-Libera mostra però un altro aspetto cruciale: l’assenza, nella percezione pubblica, di strategie chiare ed efficaci per contrastare le mafie. “Com-battere, se non battere” la criminalità organizzata resta un obiettivo condiviso ma sfuggente, percepito come difficile da raggiungere.
Tra le misure più apprezzate figura “la confisca dei beni che appartengono alla mafia”, sostenuta dall’84% del campione. Un consenso quasi unanime, che testimonia la fiducia dei cittadini nella forza simbolica e concreta di togliere risorse alle organizzazioni criminali per restituirle alla collettività. Tuttavia, non mancano le ambivalenze. Una parte significativa della popolazione ritiene che questa misura comporti costi eccessivi per lo Stato — e quindi per i cittadini stessi.
Dietro questa posizione si nasconde una contraddizione profonda: la consapevolezza che la lotta alla mafia richiede investimenti, sacrifici e continuità, elementi che spesso scontrano con la stanchezza civica e con la percezione di inefficacia delle istituzioni. È una sfida che va oltre i confini della repressione penale e che interroga la capacità dello Stato di costruire fiducia e partecipazione.
Il rischio dell’abitudine: quando la mafia diventa “normale”
C’è un dato che attraversa tutte le indagini sul tema: la mafia continua a inquietare, ma non scuote più come un tempo. Nelle risposte degli italiani, la minaccia mafiosa è percepita come costante, pervasiva, ma raramente suscita reazioni emotive forti. Questo atteggiamento è stato definito “il rischio dell’abitudine”: la tendenza, cioè, a convivere con fenomeni ostili fino a renderli parte del paesaggio quotidiano.
Accettare la presenza mafiosa come una realtà con cui fare i conti, anche se “estranea ai nostri valori, alla nostra concezione etica”, significa rinunciare a combatterla. È una forma di resa silenziosa, un adeguamento che trasforma la paura in rassegnazione. Così la mafia diventa un dato di fatto e si finisce per adeguarsi. Ma non tutto è perduto. Accanto a questa deriva di assuefazione, il sondaggio evidenzia la presenza di una parte della società che resiste.