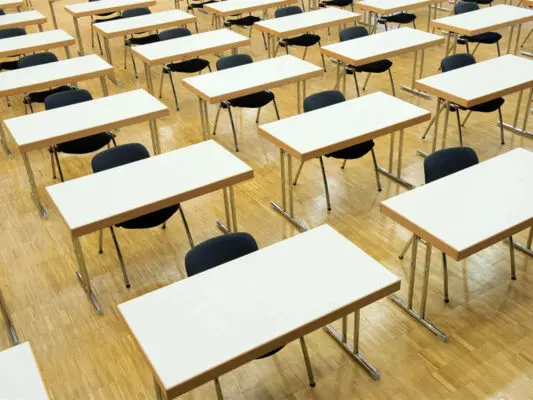L’ipotesi della Dda di Reggio Calabria sull’inquietante rete di potere e favori: nelle carte dell’inchiesta Res-Tauro la presunta infiltrazione del clan nel polo accademico. Un sistema criminale che avrebbe attraversato lo Stretto coinvolgendo professori, studenti e ospedali
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Dall’inchiesta “Res-Tauro” emerge una storia di potere, silenzi e collusioni, una storia che ha disvelato il radicamento della cosca Piromalli, storicamente egemone nella Piana di Gioia Tauro, anche all’interno dell’Università di Messina. Un’infiltrazione silenziosa ma capillare, che ha prodotto negli anni un sistema di condizionamento e controllo sul percorso universitario e sanitario, utilizzato per rafforzare la rete criminale e garantirsi “quadri” professionali compiacenti.
L’Università di Messina come terra di conquista
A raccontare l’intreccio tra i clan calabresi e l’ateneo messinese sono le carte dell’inchiesta, arricchite da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Secondo quanto riportato nelle carte vi era un’intera famiglia legata ai Piromalli, i cui membri avrebbero conseguito la laurea in Medicina in circostanze fortemente sospette nel periodo in cui era presieduta dal prof. Salvatore Navarra.
Un dettaglio tutt’altro che trascurabile: Salvatore era il fratello di Michele Navarra, noto boss di Cosa Nostra soprannominato “Il Dottore” o “U Patri Nostra”, a testimonianza di quanto la convergenza tra le mafie e le istituzioni accademiche avesse assunto un carattere sistemico.
I 18 esami in un anno e il “favore” del boss detenuto
A fornire un tassello chiave alla vicenda è il collaboratore di giustizia Marcello Fondacaro, medico anch’egli, che racconta una vicenda sconcertante: i fratelli vicini al clan avrebbero superato ben 18 esami universitari in un solo anno, nonostante «la loro scarsa preparazione». Il tutto grazie alla protezione di Domenico Piromalli, detto “Don Mommo”, detenuto proprio in quegli anni all’ospedale Piemonte di Messina. Qui, secondo quanto riferito, i Tripodi erano incaricati di assistere il boss durante il ricovero — un compito che avrebbe fruttato loro una laurea “accelerata”, grazie agli “agganci” con professori universitari compiacenti, tra cui proprio il prof. Navarra.
Una rete di controllo condivisa
Non si tratta di episodi isolati. Le udienze del processo “'Ndrangheta Stragista” hanno rafforzato il quadro: il collaboratore Cosimo Virgilio ha raccontato come, negli anni '80, l’Università di Messina fosse oggetto di interesse e spartizione tra le principali famiglie mafiose calabresi e siciliane. Secondo Virgilio, oltre ai Piromalli e ai Mancuso, anche figure come il preside Caratozzolo e suo figlio sarebbero stati al centro di rapporti ambigui con la criminalità organizzata, in particolare con famiglie come i Borgese.
La gestione dell’università non era solo accademica, ma includeva un vero e proprio “mercato” di esami e carriere universitarie, come sottolineato dai collaboratori.
Il quartiere “nostro” di Messina: una propaggine calabrese
La penetrazione della 'ndrangheta nella città dello Stretto, tuttavia, non si è limitata all’università. In una conversazione captata nel 2022 tra tre indagati dell’inchiesta Res-Tauro — Francesco Adornato, Pasquale Ferraro Randazzo e Giuseppe Ferraro — emerge un quadro preciso: Messina era considerata una “stazione portante” dei calabresi, una vera e propria base operativa. Adornato, uomo di fiducia dei Piromalli e con rapporti personali con Giuseppe Piromalli (classe ’45), spiega come, nonostante la presenza di proiezioni catanesi e palermitane, fosse stato stabilito un accordo: la città doveva essere gestita dai calabresi.
Un equilibrio mafioso, un filo rosso che ha retto per decenni, favorendo l’espansione della ‘ndrangheta e la sua capacità di infiltrarsi nelle istituzioni civili, sanitarie e accademiche.
La ’ndrangheta nelle istituzioni fuori dalla Calabria
L’inchiesta Res-Tauro ci costringe a prendere atto di un dato tanto evidente quanto spesso rimosso: la ‘ndrangheta non è più da tempo un fenomeno circoscritto alla Calabria. La sua capacità di insinuarsi nei gangli vitali delle istituzioni pubbliche, anche a centinaia di chilometri di distanza, è la chiave del suo potere.
La vicenda dell’Università di Messina - in cui esami, lauree e percorsi di carriera sarebbero stati in parte manipolati per favorire i sodali del clan - è solo una delle manifestazioni di un sistema ben più ampio. Un sistema che ha saputo costruire la sua forza non solo con la violenza, ma con l’infiltrazione, il silenzio e la complicità.
Il mondo accademico, così come quello sanitario, appare in questo contesto non solo vittima, ma in parte anche strumento di una pericolosa ragnatela criminale.