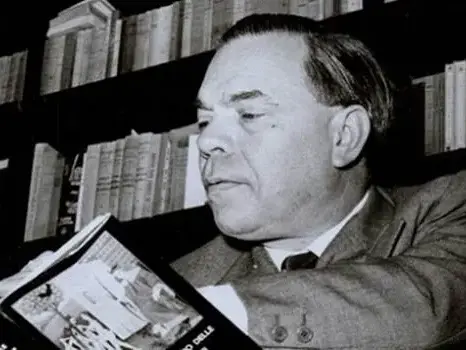Nella sua prima raccolta l’autore calabrese racconta la Grande Guerra ma vista dal basso, leggendola dalla parte degli umili e degli invisibili, quelli che sono la carne da macello della Storia
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
La Grande Guerra, prima di scriverla, Corrado Alvaro l’ha fatta, l’ha vissuta, l’ha sofferta come ricordo indelebile per tutta la vita. Dopo essere stato un passionale irredentista e interventista, come promotore di manifestazioni patriottiche a Catanzaro, nel ’15 parte da volontario, alla dichiarazione di guerra, per seguire il corso di formazione per allievi ufficiali. Poi è subito inviato al fronte, dove nel novembre di quell’anno viene ferito – quando già alcune delle sue Poesie grigioverdi venivano pubblicate sulla «Riviera ligure» – e poi congedato per sopravvenuta inabilità. Una pallottola aveva colpito il polso destro, tanto da far temere una menomazione permanente, che non gli avrebbe consentito di scrivere. Guarì, ma non del tutto.
Nel dicembre 1925 il fascistissimo e dispotico ‘padrone’ del teatro italiano, Paolo Giordani, riferiva di averlo «coperto di pugni, schiaffi e calci, ai quali egli, da quel perfetto vigliacco che è, ha reagito con la fuga». Il vigliacco era lui, invece: Alvaro non poteva reagire a causa di quella ferita inflittagli dal nemico, quando serviva la patria nella Prima guerra mondiale.
Se Polsi nell’arte, nella leggenda, nella storia era stato il suo passo d’esordio, quello più propriamente letterario è costituito da un esile volumetto di dodici Poesie grigioverdi (Roma, Lux, 1917: ma Mattinata in marcia è articolata in quattro testi), tutto imperniato sull’esperienza bellica che aveva vissuto. Ci sono echi carducciani e dannunziani, pascoliani e crepuscolari, insomma una tentazione di poesia ‘alta’, dalla quale l’autore non era riuscito ancora a liberarsi del tutto. Ma la linea portante è un’altra: Alvaro voleva dar vita a un canto disadorno, a una modulazione popolareggiante. Da moderno cantastorie, ha voluto esprimere polemicamente una visione dal basso, antieroica ed antiretorica, dell’evento bellico, colto dalla angolazione visuale di quella massa contadina che era stata chiamata a combattere come carne da macello, senza quasi conoscere le motivazioni del suo olocausto.
Ecco perché di autobiografico c’è ben poco. Alvaro ricerca una narrazione ‘corale’ della guerra, filtrata attraverso alcune tipologie di soldati che parlano per tutti. Il tessuto stilistico appare decisamente orientato verso una scelta di effetti dimessi e quotidiani, pur se rimangono pesanti scorie di letterarietà tradizionale, soprattutto nel lessico, che presenta un mancato amalgama tra l’aulico e il popolare; e la lotta tra il vecchio e il nuovo si percepisce soprattutto nella irrequietezza metrica, che già si coglieva nelle poesie, sino a poco tempo fa inedite, che Alvaro aveva scritto fra il 1912 e il ’15.
Nelle Poesie grigioverdi si direbbe, a prima vista, che il poeta è ancorato a una tradizione plurisecolare: sestine, ottave, quartine, sonetti, e dunque a una metrica chiusa. Poi invece, come in Pascoli, viene alla luce quella che ho chiamato l'irrequietezza metrica: Alvaro appare insofferente ― e non poteva che essere così ― del semplice ricalco delle forme consuete. Il sistema delle rime presenta volute alterazioni, dissonanze; e i versi sciolti si compaginano in strofe di lunghezza ampia e variata: ad esempio, uno dei testi poetici più citati, Lettera a casa, ne ha quattro (rivolte alla madre e al padre, alle sorelle e ai fratelli) rispettivamente di 34, 23, 13 e 16 versi. Le rime, anche quando Alvaro sembra ricorrere ai metri consueti, la sestina e l’ottava, presentano l'infrazione sostitutiva delle assonanze e delle consonanze o di un verso che rimane metricamente isolato, senza rispondenza.
Il verso libero si era già affermato in Italia con d'Annunzio; e Ungaretti nel dicembre 1915 scriveva Veglia: un tempo notturno, accanto a un «compagno massacrato», in versicoli che esprimevano la brutalità della guerra in spasmi dolorosi. La scelta di Alvaro è diversa: non taglia i legami con la tradizione, ma la rinnova cautamente dall'interno; e l'autobiografismo ― così tipico dell'Ungaretti di L’allegria (1919) e più in generale della poesia italiana ― in Alvaro diviene un leggersi e un riflettersi negli altri, negli umili e negli invisibili. Che cantano: la prima poesia è Canto coscritto; l'ultima, Fine, si apre su un canto che non può avere vita, perché «la terra non ha giaciglio / pei dolori e gli uomini defunti», pur se rimane la fede nella redenzione che la poesia può dare ,spargendo «i suoi germi nel mondo».
Ecco, questo è il vero nucleo del volumetto alvariano: le canzoni, il canto, il suono della tromba, punteggiano quasi tutti i testi come rimozione della fatica, dell'abbrutimento, della morte. Ma sempre la favola si straccia; e anche i colori festosi di Carri di Sicilia, che ora «corrono le strade della guerra», si convertono in ultimo nella paura del destino. L'incoscienza apparente dai vent'anni rivela il suo più tragico aspetto: l'abbandono straziante della casa e della famiglia; il gioco crudele della guerra (il soldato biondo che richiama il tiro dei cecchini austriaci, in una gara disumana a chi «lo spenge»); il contadino spaccone di Pastorale, che partendo intona un'ultima canzone, sapendo che poi non potrà più farlo «sotto i cieli / perché dovrò vegliare all'agguato»; L'artigiano soldato, il quale «non conosce un'opera perfetta / che non sia ’l solco del bove»; e l'invito, in Consolazione, a non piangere il soldato «più bello d'un olivo», che «ha scelto per suo capolavoro / la morte».
La morte, che appare adombrata o esplicitata in tutti i testi delle Poesie grigioverdi, diviene centrale negli esiti più incisivi e maturi della raccolta: A un compagno e Lettera a casa. La prima è una toccante richiesta di bugia consolatrice, che il commilitone invierà ai familiari dell'ucciso: non devono sapere «che io sia morto solo». «Di’ loro che la mia fronte / è stata bruciata là dove / mi baciavano, e che fu lieve / il colpo, che mi parve fosse / il bacio di tutte le sere». «Di’ loro che c'era gran sole / pel campo, e tanto grano», e «che mi seppelliron con tanta / tanta carne di madre in compagnia / sotto un bosco d'ulivi». Nella seconda, rivolgendosi al padre: «tu sai dove vado? / Io no, ché nel viaggio ho smarrito / amore e dolore» e ora «cerco l’ignoto». Al di là della narratività, si avverte in questi testi una tensione verso la prosa, verso una poesia che sia per qualche aspetto anche prosa. E la poesia ― come ha scritto Montale ― è «semenzaio della prosa». Per Alvaro, quella di La siepe e l’orto (1920).