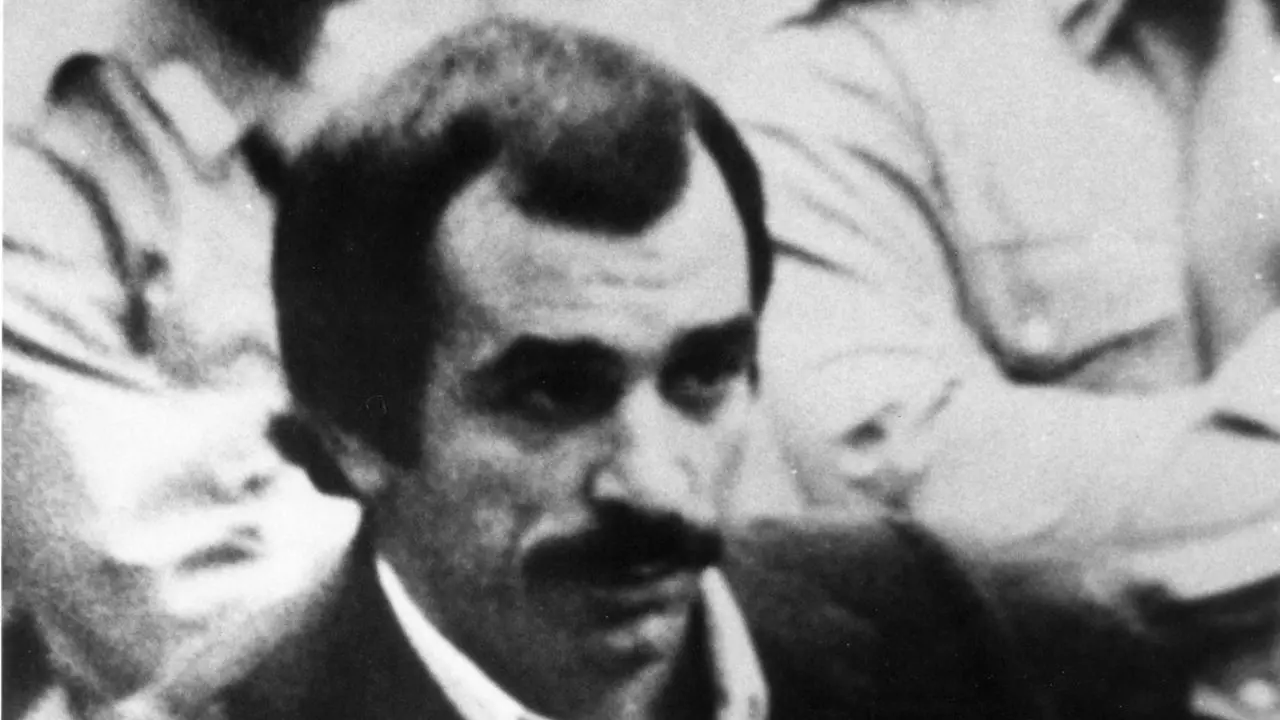Con 29 omicidi alle spalle, l’84enne fu tra i primi a raccontare ai magistrati il legame tra mafia e affari del Nord. Nel suo intervento al Rumore Festival ha ricordato il suo ruolo in quegli anni violenti: «Nel ‘91 ho parlato per far cadere un sistema, non per paura di morire»
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
«Tutto era pronto. Ci trovavamo a Milano, avevamo una bottega di copertura. Dovevamo sequestrare Silvio Berlusconi». A parlare, davanti al pubblico del Rumore Festival di Fanpage.it, è Gaspare Mutolo, uno dei killer più spietati di Cosa Nostra, uomo di fiducia di Totò Riina, poi diventato uno dei più importanti collaboratori di giustizia della storia italiana.
Mutolo, oggi 84enne, ricorda con lucidità gli anni in cui la mafia era una macchina militare e affaristica insieme. «Era il 1975 — racconta —. In quegli anni i rapimenti di imprenditori erano il modo più rapido per fare soldi. Berlusconi era un obiettivo perfetto. Io avevo già fatto due sequestri, tutto era pronto». Ma il piano si fermò di colpo: «Arrivò Nino Badalamenti, cugino del boss di Cinisi Tano, e ci disse di tornare in Sicilia. Era stato deciso di non fare più il rapimento».
La ragione, secondo Mutolo, stava in un accordo segreto. «Berlusconi lo aveva saputo tramite Marcello Dell’Utri. Si erano messi d’accordo. Avevano fatto un patto — cosa che lo Stato ha poi accertato — e decisero di inserire Vittorio Mangano nella sua villa come “stalliere”, ma in realtà come protettore. Era come mettere una bandiera palermitana davanti a casa sua, un segnale per dire: questo imprenditore non si tocca».
Le parole dell’ex mafioso riportano a galla un periodo oscuro, in cui gli intrecci tra Cosa Nostra e il potere economico del Nord erano fitti, silenziosi, spesso ignorati. All’epoca Mutolo era un uomo di fiducia del mandamento di Partanna-Mondello, fedele a Riina e responsabile di 29 omicidi. Entrò ufficialmente nell’organizzazione nel 1973, dopo un rito di affiliazione avvenuto a Napoli: un dettaglio che, come lui stesso sottolinea, dimostra quanto mafia e camorra fossero già allora alleate.
«Il mio rapporto con Totò Riina — spiega — era umano, di amicizia. Ho conosciuto i suoi lati buoni, ma anche il suo lato più cattivo, quando cominciò a circondarsi di uomini senza scrupoli. Per non essere fregato, fregava lui». Mutolo fu anche autore di azioni simboliche di intimidazione. «Nel ’68 bruciai la macchina del giudice Cesare Terranova, su ordine di Riina. L’avevano fatto infuriare perché avevano mandato al confino Ninetta Bagarella, la sua fidanzata. Mi disse: “Bruciagli la macchina”. E io lo feci».
Oggi Mutolo racconta quegli anni come un inferno che inghiottiva chiunque. Ma è il 15 dicembre 1991 la data che ha cambiato la sua vita. Quel giorno, in una stanza del Ministero della Giustizia, si sedette davanti a Giovanni Falcone e gli disse: «Ho deciso di collaborare». Sarà l’ultima volta che lo vedrà prima della strage di Capaci. «Falcone mi affidò a Paolo Borsellino — ricorda —. Ma aspettai otto mesi prima di iniziare a parlare, perché a Palermo c’erano dei veleni, dentro e fuori la magistratura. C’era chi voleva che mi affidassi ad altri giudici. La mafia di allora aveva perso ogni umanità. Ho conosciuto uomini che ordinavano di uccidere la figlia, il fratello, la sorella. Avevano smarrito persino il senso della pietà». Poi il racconto si fa più intimo: «Falcone non voleva dare sconti di pena ai collaboratori. La sua idea era diversa: voleva dimostrare che un uomo può cambiare, che la verità può redimere. Lui aveva capito che la mafia non era solo sangue, ma anche politica e affari. Con Rocco Chinnici aveva spezzato quel legame, e per questo li hanno uccisi».
Quando oggi Mutolo parla di sé, lo fa con un tono quasi dimesso, ma lucido. «Ho deciso di collaborare non per paura di essere ammazzato, ma per far cadere un sistema. Io ne facevo parte, e lo conoscevo bene. Per questo ho parlato». Il suo racconto si intreccia a quello di un’Italia che allora non voleva vedere: la Palermo degli anni Settanta e Ottanta, dove gli imprenditori si piegavano alla protezione mafiosa e lo Stato faticava a riconoscere la propria ombra. «La mafia non era quella dei film — dice —. Era ovunque. A Milano, a Torino, nei cantieri del Nord. Dove c’erano soldi, c’era anche lei».
Di Berlusconi parla senza rancore, come di un simbolo di quell’epoca: «Era un imprenditore intelligente, aveva capito come funzionava il mondo. Noi lo avevamo messo nel mirino, ma lui aveva già trovato la soluzione. E con l’aiuto di chi conosceva bene le regole di Cosa Nostra». Il racconto si chiude con una riflessione amara: «Io ho visto morire Falcone e Borsellino. Erano uomini che credevano nella legge, non nella vendetta. E io oggi sono vivo grazie a loro».
Gaspare Mutolo non cerca perdono, ma memoria. «Ho parlato — ripete — per far cadere un sistema». Un sistema che, a distanza di mezzo secolo, ancora chiede di essere raccontato.