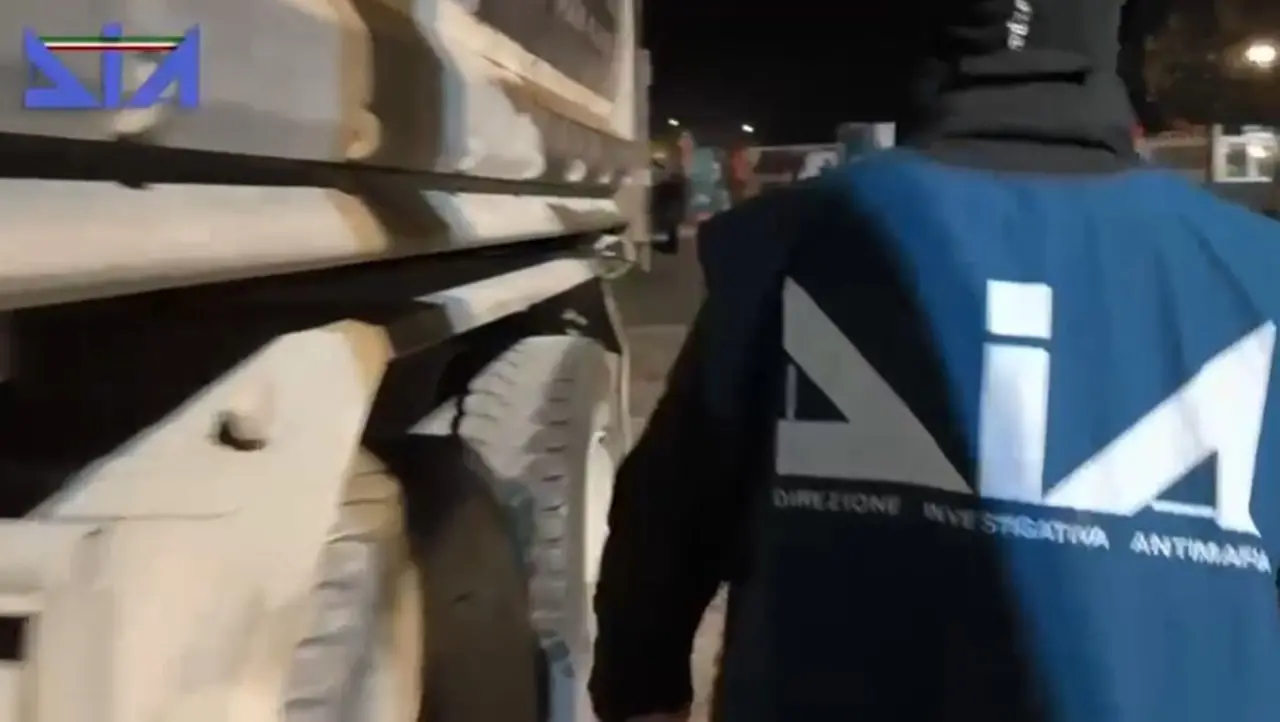Società virtuali e false fatture, finti imprenditori stipendiati e operai fantasma: l’ingegneria mafiosa usa i varchi aperti nelle leggi e mette le mani sui cantieri di mezzo Paese. Le prospettive criminali digitali del dark web
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Si tratta di un'inchiesta della Dda di Milano condotta a carico di 44 persone e nove società accusate di aver favorito le cosche mafiose di Isola Capo Rizzuto
Dopo la prima parte dedicata alle infiltrazioni nella pubblica amministrazione e alle nuove frontiere digitali, vi proponiamo la seconda parte della riflessione di Francesca Levato sulle nuove mafie.
Per eludere i controlli e aggiudicarsi gli appalti, le organizzazioni criminali ricorrono spesso ad “un terzo soggetto formalmente estraneo, una nuova società partecipata e amministrata da prestanome riconducibili alle famiglie malavitose, ma da loro formalmente distinta. Ciò viene attuato attraverso la costituzione di: società di capitali, per lo più nella forma di società a responsabilità limitata, sottocapitalizzate; società cooperative e consortili di scopo, appositamente costituite per l’esecuzione specifica di un lavoro, il cui punto di forza è rappresentato proprio dalla temporaneità della durata del rapporto, limitato nel tempo alla realizzazione dell’opera; raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti per occultare la presenza di società direttamente riconducibili ai sodalizi criminali. Assume altresì rilievo la forma di infiltrazione nell’economia operata attraverso l’imposizione alle maggiori realtà imprenditoriali, anche di carattere nazionale (interlocutori privilegiati per l’aggiudicazione degli appalti in ragione della loro storia economico -lavorativa), di imprese legate ad associazioni criminali per l’esecuzione di piccoli lavori di subappalto”.
Società cartiere mafiose: il meccanismo negli appalti pubblici
Le “cartiere” delle mafie sono società esistenti solo sulla carta e prive di reali strutture, che apparentemente prendono in subappalto i lavori affidati ad una società realmente operante e dotata di uomini e mezzi, in modo tale da rendere possibile la creazione di costi fittizi ed consentire, in generale, l’attuazione di meccanismi fraudolenti. Le “cartiere” delle mafie sono società esistenti solo sulla carta e prive di reali strutture, che apparentemente prendono in subappalto i lavori affidati ad una società realmente operante e dotata di uomini e mezzi, in modo tale da rendere possibile la creazione di costi fittizi ed consentire, in generale, l’attuazione di meccanismi fraudolenti. Si tratta di un collaudato meccanismo che permette all’impresa appaltatrice di ottenere un risparmio sugli oneri fiscali e contributivi attraverso la costituzione di una serie di società “cartiere”, intestate a prestanomi stipendiati, prive di una sede effettiva e di personale, finalizzate alla mera assunzione di squadre di operai formalmente riferiti alla singola cartiera ma in realtà sempre in carico alla medesima impresa appaltatrice.
Le false fatturazioni
La cartiera fattura i servizi relativi alla fornitura di manodopera ‒ possibile, ad es., mediante il subappalto o con il ricorso al distacco del proprio personale all’appaltatrice ‒ e può così annotarne i costi deducibili all’interno della propria contabilità: dopo un breve periodo di attività, la cartiera viene sciolta, spesso in passivo, e tramite la distruzione della contabilità veniva dissimulata l’inesistenza dei costi ingiustificatamente compensati. Si tratta, apparentemente e formalmente, di entità autonome, mentre, in realtà, sono propaggini fittizie della società appaltatrice create appositamente per fungere da schermo e consentire di raggiungere illeciti vantaggi, anche fiscali. I lavori vengono sì realizzati, ma si tratta di lavori solo apparentemente imputabili alle “cartiere”, in quanto il personale di fatto è riconducibile all’appaltatrice e da questa retribuito. Irrilevante è dunque la circostanza per la quale gli importi fatturati dalle cartiere vengono effettivamente pagati dalla appaltatrice poiché le “cartiere” sono riconducibili al medesimo centro d’interessi economici che fa capo all’appaltatrice medesima ed i pagamenti costituiscono un trasferimento di denaro solo apparente in quanto i fondi rimangono sempre nell’ambito del medesimo centro d’interessi rappresentato dai titolari dell’appaltatrice e dai loro sodali. Nella specie, non v’è la “classica” fatturazione tra oggetti estranei solo allo scopo di frodare il fisco, facendo fittiziamente figurare il compimento di operazioni mai realizzate, quanto piuttosto un meccanismo che prevede, ad opera di un unico centro direzionale, la costituzione di società esistenti solo sulla carta e prive di reali strutture, che avrebbero dovuto apparentemente prendere i lavori in subappalto dall’unica società realmente operante e dotata di uomini e mezzi ‒ l’appaltatrice ‒ in modo tale da rendere possibile la creazione di costi fittizi ed consentire, in generale, l’attuazione di meccanismi fraudolenti.
I ruoli nel sistema criminale
Si tratta di responsabilità per la configurabilità del reato associativo tra i soggetti, infatti oltre alla partecipazione di tutti al compimento dei reati fine, ognuno dei membri del sodalizio criminoso svolge un ruolo preciso: un componente ha una funzione direttiva della strategia complessiva, un altro componente, a stretto contatto con altri, si occupa dell’organizzazione e del concreto andamento del “sistema” illecito, altro ancora mette a disposizione del gruppo le proprie conoscenze e la propria esperienza in materia tributaria, ed un ultimo componente funge da prestanome di talune società, occupandosi, tra l’altro, della restituzione alla fonte dei fondi pervenuti a tali società per le fatture relative ad operazioni inesistenti.
Il sistema messo in piedi così non viene realizzato al fine di perpetrare un numero definito e limitato di reati, ma serve, piuttosto a rendere possibile l’attuazione di un numero indeterminato e potenzialmente illimitato di illeciti penali, con la conseguente configurabilità dell’associazione a delinquere e non del semplice concorso di persone nella commissione dei vari reati. La magistratura indaga sempre su casi simili e lo schema che ne emerge è quello della associazione mafiosa di cui all’art 416 bis del codice penale, con una sempre più farraginosa e complicata attività investigativa finalizzata alla ricostruzione del nesso strumentale e di causalità, con la sempre più complessa ricostruzione delle responsabilità in capo ai singoli soggetti operanti in tali sistemi e ragnatele fitte di stampo criminale.
Follow the money
La frase "Segui i soldi e troverai la mafia" è un'espressione attribuita a Giovanni Falcone, che sintetizza il suo metodo investigativo per smantellare le organizzazioni criminali, in particolare la mafia. Questo metodo, noto anche come "follow the money", si basa sull'idea che le attività illecite, come quelle mafiose, lasciano sempre una traccia finanziaria. Tracciando i flussi di denaro, è possibile individuare i responsabili e i loro legami, arrivando a colpire il cuore dell'organizzazione criminale.
Così la ‘ndrangheta sfrutta le leggi sul lavoro
Le organizzazioni criminali, in particolare la 'ndrangheta, sfruttano gli istituti giuslavoristici di esternalizzazione di manodopera, in particolare i distacchi, per far lavorare persone legate al clan in aziende e cantieri, sia regolarmente assunte che in nero, spesso senza le competenze necessarie, per favorire l'acquisizione di appalti o per riciclare denaro. La 'ndrangheta, in particolare, è nota per l'utilizzo sistematico dei distacchi, come dimostrato da numerose operazioni antimafia che hanno svelato come le aziende infiltrate gestivano i distacchi per nascondere le loro attività illecite. Le vicende emerse in questi anni ci hanno posto di fronte alla capacità delle organizzazioni criminali di far fronte ai mutamenti e alle richieste del mondo imprenditoriale e alla sua capacità di intervenire all’interno delle maglie delle regole e non già contro le regole. In questo quadro il distacco lavorativo è l’istituto sistematicamente utilizzato per regolare il rapporto tra imprese aggiudicatarie di appalti pubblici e ditte legate a gruppi mafiosi.
Il dispositivo del distacco dei lavoratori è previsto dal D.lgs 276 del 2003 e sancisce che, per determinati periodi di tempo e per lavori che esigono professionalità particolari, una ditta possa chiedere di “affittare” operai da un’altra impresa in presenza di particolari requisiti. Di fatto in questi casi l’utilizzo del distacco lavorativo simula la somministrazione fraudolenta di manodopera per cui la società distaccante, a volte anche creata ad hoc, mette a disposizione della distaccataria il numero di operai richiesti e per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle opere. Operai che di fatto lavorano per conto della stessa committente, spesso in condizioni di sfruttamento lavorativo. Questa modalità si rivela vantaggiosa per entrambi i contraenti grazie all’elusione del regime fiscale e previdenziale e la violazione delle norme in materia di subappalto, tutela del lavoro ed anti-mafia.I lavoratori, spesso in condizione di grave subordinazione, vengono pagati meno del dovuto e lavorano in condizioni precarie e di violazione delle norme sulla sicurezza, sottoposti ad abnormi orari di lavoro. A questo punto è necessario approntare le misure necessarie per contrastare l’utilizzo distorto del distacco lavorativo in funzione della tutela dei diritti dei lavoratori e del reale contrasto alla criminalità organizzata, anche alla luce dell’istituto del contratto di rete ex lege previsto e della forma dei distacchi infrarete.
Contratto di rete e distacco di manodopera
Secondo l’art 3 comma 4ter d.l. 5/2009, “4-ter. “con il contratto di rete più imprenditori (nell’accezione pura del termine) perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
Il Legislatore ha, infatti, inteso codificare uno strumento negoziale volto ad agevolare le sinergie fra imprese dirette al reciproco sviluppo industriale e commerciale cosicché la mancanza del presupposto preliminare dell’effettività dell’impresa rende, di fatto, l’adesione alla rete priva di alcuna valida causa giustificativa e nullo il relativo vincolo negoziale. La rete di imprese è una tipologia di associazionismo imprenditoriale su base contrattuale che permette alle singole imprese aderenti, “retiste”, di collaborare. Il contratto di rete permette alle imprese di conservare però la propria autonomia, ma allo stesso tempo di far parte di un'organizzazione articolata che permette di affrontare il mercato con un approccio più forte. Nel contratto di rete è necessario quindi che ciascuna parte contraente eserciti una propria ed autonoma attività imprenditoriale. È evidente che l’esistenza di un’impresa effettiva o, quanto meno, della collaborazione fra imprese per lo sviluppo reciproco costituisca una condizione essenziale per l’astratta configurabilità di una valida adesione ad un contratto di rete. Al fine di rispondere al programma di rete i singoli datori di lavoro possono usare il contratto di distacco ex art 30 D.lgs 276/03 oppure la codatorialità. Mediante il distacco il lavoratore dipendente viene temporaneamente inviato a svolgere la propria attività lavorativa presso un altro datore di lavoro distaccatario, che ne utilizza temporaneamente le prestazioni lavorative all’interno della propria organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003. Elemento peculiare del distacco è la trilateralità del rapporto, al quale prende parte, oltre al datore di lavoro distaccante ed al lavoratore distaccato, anche un terzo soggetto (distaccatario) che viene ad assumere personalmente il potere direttivo sul lavoratore controllando il suo operato, ma che comunque non riveste il titolo di nuovo datore di lavoro. Requisito essenziale ed imprescindibile di legittimità del distacco è l’interesse del datore di lavoro distaccante: l’interesse può ritenersi coincidente con una qualsiasi motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa del distaccante, purché esso sia specifico (nel senso che necessita di una esatta individuazione, senza riferimenti generali e non circostanziati ad attività, fatti o situazioni contingenti); rilevante e concreto (nel senso che non deve avere astratta attinenza con i processi produttivi o logistici aziendali, ma diretta e immediata incidenza su almeno uno di essi.
Le regole da seguire per il distacco dei lavoratori
Il patto con il quale il lavoratore viene ad essere distaccato deve trovare diretta rispondenza in un interesse che non sia generale ed astratto, ma che, al contrario, risulti perfettamente aderente alla realtà gestionale dell’organizzazione datoriale interessata); persistente per tutta la durata del distacco (nel senso che deve permanere per tutta la durata del distacco e sussistere fin dal primo momento dell’attivazione di esso). Il distacco, inoltre, per essere valutato lecito, deve prevedere lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato: il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante come declinato nell’accordo di distacco. Ne consegue che il provvedimento di distacco non può risolversi in una mera messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e, quindi, senza predeterminazione di mansioni. Posta, quindi, la necessaria presenza, ai fini dell’autenticità del distacco, dei sopraindicati elementi qualificanti, si configura un distacco illecito e/o illegittimo laddove vi sia svolgimento di attività lavorativa in costanza di accordo di distacco senza l'indicazione di un interesse concreto e qualificato.
L’illegittimità determina una “interposizione vietata di manodopera ovvero la fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei limiti di cui al D. Lgs. n. 276/2003, finanche a prevedere la conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo all’azienda (distaccataria) nel medesimo livello contrattuale posseduto nel caso di accertamento della presenza di dolo specifico e su richiesta all’A.G. competente. L'interesse del distaccante, dunque, è il fulcro della fattispecie legittima di distacco e deve essere sempre individuabile e dimostrabile. Il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che però non coincida con quello di lucro connesso alla mera somministrazione di lavoro. Infatti, ciò che differenzia i due istituti è il solo interesse del distaccante, poiché mentre il somministratore realizza unicamente l’interesse produttivo alla somministrazione ai fini del suo profitto, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato come l'interesse al buon andamento dell’impresa.
L'interesse, inoltre, non deve avere necessariamente carattere economico, basato su una maggior convenienza o un maggior guadagno, ma deve avere una rilevanza giuridica tale da giustificare la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa il meccanismo presuntivo dell'interesse del distaccante non può portare ad utilizzare la rete quale “scudo” rispetto alla liceità dello stesso, facendo venire meno l'onere di individuare una valida ragione a supporto dell'intero negozio. Negli accertamenti investigativi devono emergere e devono essere provati una serie di elementi fattuali dai quali risulta inevitabile dedurre l’assenza di qualsivoglia interesse del distacco se non quello della somministrazione di manodopera, con la messa in atto della costituzione di un mero “serbatoio di manodopera” basato sulla persecuzione del dolo specifico di “risparmiare” sia a livello retributivo sia a livello previdenziale ed assicurativo. E' sempre necessaria un'analisi attenta della complessiva operazione, volta ad escludere che il ricorso alla rete di impresa funzioni da mero strumento alternativo alla somministrazione di manodopera (cfr nota INL 274/2020 del 22.6.2020).
Ancora, stante l’automatismo normativo della supposizione dell’interesse nel distacco nel contratto di rete, comunque è necessario verificare se il distacco è avvenuto già in occasione dell’avviamento (o meglio se quest’ultimo sia stato realizzato al mero fine del distacco) e se si tratta di distacchi generici (non riferibili cioè a specifiche qualità professionali) e massivi per qualifiche a cd “bassa professionalità” ed a lavorazioni “labour intensive” .Tale illegittimità determina una “interposizione vietata di manodopera ovvero la fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei limiti di cui al D. Lgs. n. 276/2003, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo all’azienda (distaccataria) nel medesimo livello contrattuale posseduto, e laddove il lavoratore, debitamente informato, volesse radicarne la richiesta in capo al giudice competente.
Un varco per infiltrare gli appalti
Tramite tali istituti giuslavoristici le organizzazioni criminali trovano un valido varco per l’ingresso nella rete di appalti: infatti le distaccanti non sono società obbligate alla iscrizione nelle Bdna (Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia ex art 96 D.lgs 159/2011) e pertanto sfuggono ai controlli antimafia e non risultano in evidenza in alcuna documentazione dell’appalto (sia ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ex T.U.81/08 che in materia del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 36/2003).
La tendenza alla “fuga dalle regole” da parte della moderna impresa a rete, che intende “trasformare i rapporti di lavoro sfuggendo dalla tutela degli stessi, che vuole avere pochi dipendenti stabili e centinaia in distacco a fronte di commesse di altissimo valore economico” e per raggiungere questo modello deve sfuggire dalle regole legislative storicamente determinate; quindi, alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa di settore è quanto di più tipico ci sia. Praticamente è il nuovo modello imprenditoriale che cerca di scappare dal vecchio, un modello nuovo che tenta l’illegalità”. Perciò le modalità di controllo non possono tradursi in un controllo formale delle certificazioni antimafia, ma deve assumere le condizioni e le modalità di regolazione del lavoro come criterio fondamentale di giudizio.
Una campagna di monitoraggio dell’ispettorato del lavoro
Per questo sarebbe opportuno richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’effettuazione di una campagna di monitoraggio presso i grandi cantieri aperti da cui si possa rendere conto del fenomeno del distacco; rendere esplicita una clausola specifica all’interno dei Protocolli per la legalità che renda obbligatorio la comunicazione alle locali Prefetture dell’esistenza di contratti di distacco lavorativo in essere; promuovere una campagna di sensibilizzazione per le pubbliche amministrazioni e le società partecipate perché mettano in atto tutti gli strumenti necessari al controllo del corretto utilizzo del distacco lavorativo. Sarebbe auspicabile anche che in sede di bando di gara si predisponesse un sistema di premialità per le società che non fanno ricorso al distacco di manodopera.
Il valore della trasparenza
La trasparenza è la qualità di un governo e di un’amministrazione di rendere accessibili dati e informazioni ai cittadini, in modo che questi ultimi possano partecipare consapevolmente al dibattito pubblico. La trasparenza è un importante strumento per ridurre la disinformazione tra potere pubblico e collettività; inoltre, è lo strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione ed i governi danno conto dei risultati delle politiche e dell’integrità dei processi decisionali.
L’integrità pubblica fa riferimento ad un consolidato allineamento e a una costante osservanza di valori etici condivisi, principi e norme, al fine di difendere e dare priorità all’interesse pubblico rispetto gli interessi privati. Nell’ottica di un Governo aperto, l’accesso a dati e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni si configura come un servizio finalizzato a rendere conoscibili attività e processi decisionali, riducendo il gap cognitivo con cittadini, imprese e, più in generale, portatori di interesse. In assenza di questo servizio, da un lato, la collettività non è in grado di monitorare l’operato di un decisore pubblico, la qualità di un’opera o l’efficacia di una politica (lack of accountability); dall’altro, l’amministrazione pubblica potrebbe non possedere tutte le informazioni utili a pianificare e attuare efficacemente le politiche pubbliche.
La simmetria informativa resa possibile attraverso la messa a disposizione di dati e informazioni, pertanto, permette di promuovere più adeguate forme di partecipazione alle decisioni e più efficaci meccanismi di controllo sull’integrità dei processi decisionali, sulla qualità della spesa pubblica e sull’efficacia delle politiche pubbliche.
Il ruolo del dark web
L’uso dei dati nella rilevazione dei fenomeni corruttivi è largamente riconosciuto come uno dei meccanismi più efficaci al fine di comprendere dove e come si manifesta la corruzione e combatterla con misure sempre più raffinate. La trasparenza dei dati e delle informazioni, pertanto, gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione, ma anche ai fini della promozione della cultura dell’integrità e, nello specifico dell’integrità dei processi decisionali pubblici. Ed è proprio l’assenza di trasparenza che richiama oggi nella cronaca nera il fenomeno dell’anonimato digitale, un canale invisibile di internet, una nuova e perversa agorà senza alcuna forma di responsabilità e di identificazione. Il carattere distintivo del dark web risiede nel principio di responsabilità. A differenza del surface web – dove l’accessibilità pubblica e l’indicizzazione garantiscono tracciabilità – e del deep web – protetto da credenziali ma comunque associabile a identità reali – questa dimensione compromette intenzionalmente il legame tra identità digitale e soggetto fisico/giuridico.
Per chiarire con alcuni esempi: l’accesso a un portale d’informazione pubblica rientra nel surface web; la consultazione di archivi universitari protetti caratterizza il deep web; la navigazione in ambienti dove contenuti e identità sono occultati volontariamente definisce il dark web. Prima si usavano “i pizzinni ma oggi la rappresentazione mediatica del dark web come ricettacolo di criminalità risulta quindi fondata. Questa rete ospita infatti una varietà comparabile al web convenzionale: comunità di attivismo politico, archivi di documenti censurati e piattaforme per il giornalismo investigativo coesistono con mercati illegali.
I fenomeni criminali (dal traffico di stupefacenti alla pedopornografia) rischiano tuttavia di eclissare le criticità insite in un web completamente governato da algoritmi e soggetto a controllo centralizzato, specialmente in regimi autoritari.
I traffici illeciti sulle piattaforme digitali
Le statistiche sulle attività illecite rimangono allarmanti, con un volume significativo di transazioni riguardanti armi, droghe e materiale abusivo. Questi dati impongono una valutazione equilibrata che riconosca tanto i rischi quanto le potenzialità democratiche insite nella tecnologia. Il dark web rappresenta oggi una delle frontiere più complesse e sfuggenti nel rapporto tra legalità e illegalità, offrendo uno spazio in cui la criminalità organizzata può operare con modalità nuove e difficilmente tracciabili. Attraverso piattaforme come Silk Road, AlphaBay e numerosi altri marketplace digitali, le organizzazioni criminali hanno trovato un ambiente ideale per espandere traffici illeciti di ogni genere, dalla droga alle armi, fino ai servizi di hacking e riciclaggio di denaro.
L’anonimato garantito da strumenti come Tor e dalle criptovalute ha reso possibile la nascita di economie parallele, dove le regole del mercato legale vengono sistematicamente aggirate e la responsabilità individuale si dissolve in una rete di identità digitali difficilmente rintracciabili. In questo contesto, la mafia italiana e altre organizzazioni internazionali simili hanno dimostrato una notevole capacità di adattamento, integrando competenze informatiche e strategie digitali per gestire affari illeciti su scala globale, superando i confini nazionali e le barriere giuridiche. L’anonimato offerto dal Dark web facilita dunque una serie di attività criminose e rappresenta quindi una sfida per quanto riguarda la legalità degli ambienti e dei comportamenti digitali. Ciononostante, è fondamentale adottare sempre una prospettiva critica e consapevole, per fare in modo che questi fenomeni non offuschino completamente le possibilità democratiche e di partecipazione attiva abilitate da queste stesse reti. “Le mafie evolvono, si aggiornano anche e soprattutto tecnologicamente: per noi e le forze dell’ordine non è semplice seguirle e inseguirle, specie nel dark web, dove scambiano somme impressionanti di bitcoin e dove gestiscono ogni sorta di attività illecita”. Così il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha lanciato un nuovo allarme, incentrato in particolare sulle nuove sfide tecnologiche attraverso le quali passa oggi l’eterna lotta tra bene e male.
*Ispettorato nazionale del lavoro