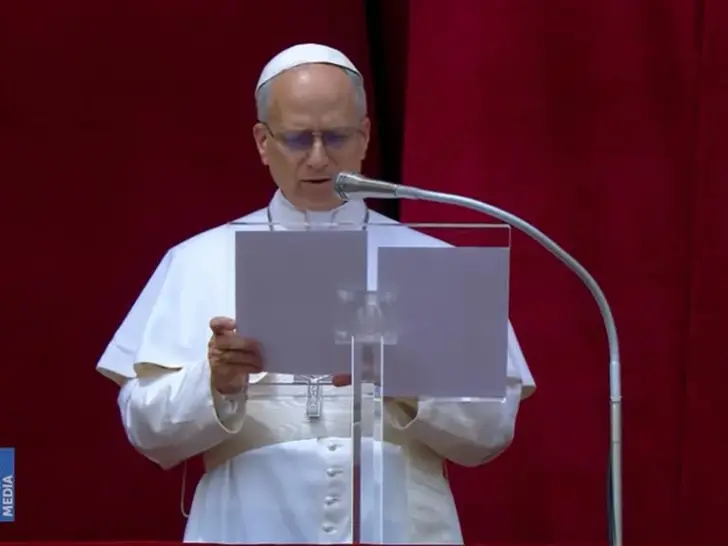La liberazione degli ostaggi israeliani, il cessate il fuoco, la firma dell’accordo in Egitto: ore decisive per il futuro in una terra dilaniata e segnata dalla morte
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Profughi palestinesi rientrano a Gaza
Settantadue ore per la pace: ostaggi, aiuti e la polvere della storia. Da Gaza City e Sharm el-Sheikh, 13 ottobre 2025
La tregua
La tregua è cominciata all’alba, ma a Gaza l’alba non si distingue più dal tramonto. La luce cade sul cemento come una polvere vecchia, e i primi camion umanitari entrano lenti, seguiti da occhi stanchi, da mani che sollevano cartoni d’acqua come fossero reliquie. È la prima tregua in due anni esatti di guerra. Settantadue ore per tentare la pace, per restituire ostaggi e corpi, per riprendere fiato in un luogo che di fiato ne ha perso troppo.
Hamas ha annunciato che da lunedì mattina inizierà il rilascio dei quarantotto prigionieri israeliani. Dall’altra parte, Israele ha già aperto le porte di alcune carceri: circa duemila detenuti palestinesi torneranno a casa. È uno scambio che non cancella nulla — né i morti, né le macerie — ma è un gesto, e nei giorni che vengono i gesti valgono più delle parole.
Le rovine
I numeri della tregua sono ancora scritti a matita. L’Idf si è ritirato parzialmente fino alla “linea gialla”, mantenendo però il controllo del cinquantatré per cento della Striscia. A Rafah restano le truppe, i carri armati, gli occhi puntati sull’orizzonte. Cinquecentomila palestinesi hanno già fatto ritorno verso nord, a Gaza City, ma quello che trovano non è casa: è un miraggio di case, un mosaico di pareti spezzate, scale che non portano più da nessuna parte. «Non è rimasto più niente», dicono ai microfoni di Al Jazeera. E in effetti non è rimasto nulla, se non la volontà testarda di esistere.
Le Nazioni Unite calcolano cinquantatré milioni di tonnellate di macerie: sette piramidi di Cheope frantumate sul Mediterraneo. Il novantaquattro per cento degli ospedali è distrutto, il novanta per cento degli appartamenti non esiste più, il settantasette per cento delle scuole è ridotto in polvere. Ci vorranno vent’anni e almeno un miliardo e duecento milioni di dollari solo per sgomberare il terreno. Ma il conto vero, quello che non entra nei bilanci, è il tempo rubato: ventiquattro mesi di fame, di sete, di sirene, di bambini sepolti. Sessantamila morti, di cui diciottomila erano bambini. Ogni cifra è un cimitero di nomi.
Il paradosso del silenzio
Nelle stesse ore in cui i camion carichi di aiuti varcano il confine, diciannove palestinesi vengono uccisi dai bombardamenti israeliani. Il cessate il fuoco è un foglio di carta sottile: basta un ordigno a strapparlo. Una casa, quella della famiglia Ghabboun, è stata centrata in pieno. Sedici persone, la stessa stirpe, cancellate in un istante. «Non c’è tregua che basti se non si smette di odiare», ha detto un funzionario dell’Onu a Khan Younis, dove l’ottanta per cento della città è distrutto e le strade sono sepolte da quattrocentomila tonnellate di macerie.
L’agenzia israeliana Cogat conferma: alcuni camion di aiuti sono entrati a Gaza. Ma l’immagine più nitida di queste ore è quella del mare che osserva, immobile, i resti di un porto. Lì dove una volta attraccavano le barche dei pescatori, ora galleggiano gli scheletri di gommoni umanitari. La Global Sumud Flotilla, con a bordo centinaia di attivisti civili, è stata intercettata e bloccata a settanta miglia dalla costa. Non portavano armi, portavano farina, garze, siringhe, latte in polvere. Ma sono stati fermati: la pace, a volte, pesa più di una minaccia.
La politica e le sue ombre
Gli Stati Uniti hanno invitato l’Iran a unirsi ai negoziati di pace di Sharm el-Sheikh. Lunedì, nella località egiziana, Donald Trump e Abdel Fattah al-Sisi presiederanno la cerimonia ufficiale della firma, insieme ai rappresentanti di Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Qatar, Turchia e Arabia Saudita. L’Italia sarà rappresentata dalla premier Giorgia Meloni. Lì si decideranno i prossimi passi: il disarmo di Hamas, la governance di Gaza, la creazione di una zona cuscinetto e di una forza internazionale di stabilizzazione con partner arabi.
Ma Hamas ha già detto no: «Assurdo pensare che lasceremo la Striscia o consegneremo le armi» E ha rifiutato di partecipare alla cerimonia, lasciando che siano i mediatori egiziani e qatarioti a rappresentarla. La verità è che questa tregua non è pace: è una pausa nel rumore. Un modo per respirare prima che la storia decida cosa fare dei vivi.
Il ritorno
Dopo due anni di guerra, Gaza è una città fantasma dove l’aria sa di ferro e di carne, dove le finestre sono occhi ciechi. Eppure i suoi abitanti tornano. Tornano a cercare le chiavi sotto le macerie, a riconoscere i cortili, a contare i morti come si conta la memoria. Tornano anche senza un tetto, perché il ritorno è l’unica forma di dignità che resta.
Gli Stati Uniti hanno promesso fondi, piani di sviluppo, un “nuovo Medio Oriente” fatto di investimenti e turismo, di spiagge ricostruite e porti rinnovati. Ma la sabbia di Gaza non dimentica. Ogni granello racconta un nome. Ogni muro rimasto in piedi sa che sotto di lui dorme qualcuno. Le organizzazioni umanitarie hanno già pronti seicento camion di aiuti al giorno: tonnellate di cibo, medicinali, tende. Ma i valichi sono pochi, e ogni valico è un collo di bottiglia tra il diritto e la politica.
La frattura d’Israele
Nel frattempo Israele è diviso come non mai. Netanyahu è ancora in piedi, sorretto da alleati che premono per un’annessione totale della Striscia. Le piazze di Tel Aviv e Gerusalemme, da mesi, si riempiono di genitori che chiedono il ritorno dei figli sequestrati. Alcuni hanno montato tende davanti alla residenza del premier: le chiamano “le tende della verità”. Lì, ogni notte, si accendono candele e si pronunciano nomi. È la coscienza di un Paese che comincia a dubitare della sua stessa forza.
Donald Trump arriva come un regista tornato sulla scena per firmare il suo finale. Parla di «una Gaza deradicalizzata, libera dal terrorismo e pronta a rinascere come la riviera del Medio Oriente». Ma la pace non si produce in serie, e la storia non obbedisce agli slogan. Gaza non è un progetto immobiliare: è un dolore collettivo che non si cancella con un tweet o con una cerimonia.
L’umanità che resta
Eppure, tra tutte le menzogne e le strategie, c’è un piccolo miracolo civile: mezzo milione di palestinesi sono tornati verso nord, sapendo che troveranno solo polvere. Hanno camminato lungo le strade distrutte, tra i cavi scoperti, tra i resti di un passato che non c’è più. Una donna, intervistata dalla CNN, ha detto: «Non mi interessa se la mia casa non esiste. Voglio dormire dove è morta mia madre». E in quella frase c’è tutta la verità che nessun piano di pace potrà mai scrivere.
Il coraggio di non ricominciare
La tregua durerà se le parole troveranno corpo. Ma la pace, quella vera, non è una firma. È una quotidianità da ricostruire mattone dopo mattone, come il suono di una città che lentamente ricomincia a respirare. Un respiro stanco, spezzato, ma ancora vivo. Forse un giorno, in un futuro che oggi pare incredibile, Gaza avrà di nuovo un porto, un mercato, un orizzonte senza fumo. Ma per arrivarci bisognerà imparare a fare la cosa più difficile: restare umani anche dopo tutto questo. Perché la pace non si vince, si custodisce. E quella che nasce oggi — fragile, incerta, ginocchioni sulle rovine — non è ancora la fine della guerra. È solo il coraggio di non ricominciare.