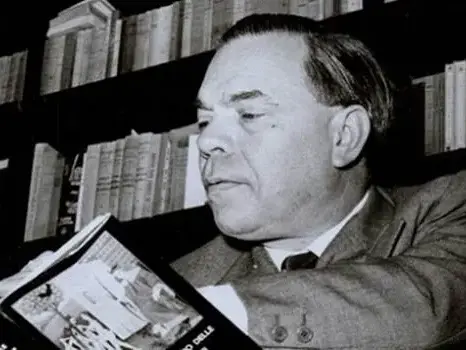Sebastiano Babel, il protagonista del romanzo è secondo lo scrittore «il primo esemplare di quella letteratura degli uomini traballanti del dopoguerra che formò un’epoca»: una narrazione che si apre alle suggestioni di Dostoevskij e di Bontempelli nella rivelazione della patologia contemporanea
Tutti gli articoli di Leggendo Alvaro insieme
PHOTO
Corrado Alvaro
Con le due novelle impiegatizie di Alessandro Rossi («La siepe e l’orto») siamo già a quella tematica dello sradicamento, dell’alienazione, dell’emarginazione nella solitudine della città che caratterizza il primo ambizioso tentativo di Alvaro nel genere del romanzo: «L’uomo nel labirinto» (1926). Fu iniziato nel 1921 a Parigi, poi rielaborato a partire dal ’24 e pubblicato solo nel ’26 per l’editore Alpes di Milano, dopo aver avuto non pochi problemi con la censura. Contro il regime mussoliniano la voce di Alvaro si era levata alta e ferma dalle colonne del «Mondo» e del «Becco giallo» (e, più larvatamente, dal profilo biografico di «Luigi Albertini»), dopo essere tornato a Roma già nel corso del 1922 per coadiuvare da vicino la crociata di Amendola nella lotta alle forze della illibertà. Non a caso «L’uomo nel labirinto» ebbe il permesso di stampa solo grazie all’intervento di Massimo Bontempelli, del quale Alvaro condivise da vicino, a partire dal 1926, l’avventura di «900», divenendo segretario di redazione della rivista.
Con questo romanzo Alvaro si scioglie definitivamente dall’arte in parte ancora grezza e disadorna delle «Poesie grigioverdi» (1916) e di «La siepe e l’orto» (1920): ha inizio l’esplorazione della malattia tutta moderna del vegetare e del corrompersi nell’anonimato degli agglomerati urbani, anche grazie alla suggestione della narrativa russa, e in particolare di Dostoevskij. È un’indagine, però, che non comporta l’allontanamento della sua opera dalla fonte ispirativa. La scrittura alvariana ― come si è già annotato ― congiunge il microcosmo della Calabria (il paese dell’anima che funge da sostrato a tutto il suo itinerario creativo; la linea alta e irradiante di tutta una tradizione letteraria e civile, dalle radici magnogreche a Gioacchino da Fiore, da Campanella a Padula) e la realtà europea, in cui Alvaro andava ad innestarsi, ma senza estirpare le antiche radici, senza cancellare l’identità storico-culturale dei padri. Ognuno dei due poli — la tradizione (come ancoraggio dell’identità e della memoria) e la contemporaneità — non si situa con l’altro in un rapporto di opposizione, ma invece si colora del suo riflesso, è (ri)vissuto alla luce di esso, in un unico sistema circolatorio.
La novità vitale dell’arte alvariana è questa interazione tra i due mondi, la provincia e il continente, che reciprocamente si rivelano. È un’evoluzione che ha inizio proprio con «L’uomo nel labirinto», imperniato sulla tematica dello sradicamento dal paese e dell’emarginazione nella solitudine della città. Dal gennaio del 1922 Alvaro si era trasferito come corrispondente di «Il Mondo» (diretto da Giovanni Amendola) nella capitale francese, allora epicentro delle forze più vitali dell’avanguardia letteraria (a cominciare da Joyce e dagli ‘esuli’ americani: Stein, Fitzgerald, Hemingway ed Eliot). Il contatto stimolante con questa nuova realtà si manifesta chiaramente nello sperimentalismo di «L’uomo nel labirinto», per l’autore “il primo esemplare di quella letteratura degli uomini traballanti del dopoguerra che formò un’epoca”.
Il romanzo, narrato in terza persona dal punto di vista del protagonista e denso di un descrittivismo oggettuale che strania il racconto e marca le solitudini, si apre con la descrizione di un risveglio primaverile, che dà il “fastidio dell’essere vivi”. Sebastiano Babel sa solo guardare la vita, senza poterla vivere; e costituisce l’antitesi di Alessandro Rossi nella sua incapacità di divenire un ingranaggio della società di massa. Inventore di strumenti tecnologici “di conforto e di risparmio”, che per accidia non sa mettere a frutto, si sente rigettato indietro dalla vita “come un sasso scagliato contro una ruota in movimento”; e sopravvive, consumando un gruzzolo messo insieme in anni lontani, nell’atonia squallida della insignificanza e della emarginazione in una città, che non è la sua, ed in una casa in cui non ha altri rapporti che quelli di una algida e stanca quotidianità con la moglie Anna, della quale desidera la morte, perché con la sua bellezza imprigionata è il simbolo stesso del fallimento esistenziale del marito.
Dopo che l’evento luttuoso si è compiuto, Babel si rinchiude in un misero alberghetto e tenta invano di rimuovere il ricordo tormentoso della moglie attraverso una costellazione di incontri erotici degradanti (il più delle volte immuni dalla congiunzione carnale) con donne sensuali e grasse, di contro alla figura slanciata ed elegante di Anna. Poi parte alla volta del paese natale con May, l’amante, «immagine rinvilita e piccola» della moglie: sin dall’inizio del viaggio, però, deve constatare l’impossibilità di instaurare una comunicazione autentica con una donna di un’altra razza, di un’altra sensibilità. Nell’isola eoliana di Vulcano, dove si sono recati quasi per una sorta di iniziazione al ritorno nel paese natìo, Babel l’abbandona tra le rovine di una villa resa friabile dai vapori sulfurei (e qui l’influsso del realismo magico bontempelliano è ben percepibile: la precisione realistica dei contorni si dissolve in una interna inquietudine, che proietta gli elementi in “un’altra dimensione”). Anche il reinnesto nel grembo materno del paese si rivela uno scacco: ciò che era stato assaporato nel ricordo, si immiserisce e si rattrappisce nella realtà del vissuto. Babel si rinchiude allora in una nuova e diversa solitudine, declamando pateticamente in una stalla abbandonata le lettere di pentimento a May, mai spedite, che perdono la consistenza di parole per divenire puri ritmi sonori.
Inetto antieroe grigio e ipocondriaco, oppresso da un’angoscia che egli imputa allo sradicamento dal paese e che lo spinge a tuffarsi nevroticamente in gomitoli di strade, tra le selve dei palazzi, il Babel alvariano pratica il piacere perverso della crudeltà e della sessualità distorta, ma si appaga masochisticamente solo della propria abiezione, confinandosi in un labirinto carceriale di ossessioni interiori. È una patologia dell’anima che proietta la disfatta esistenziale del personaggio ― percorsa vitalmente da suggestioni dostoevskijane ― in un ipogeo senza possibilità di catarsi, per esprimere la desolazione e l’aridità, il grigiore umiliato e l’abulia autoflagellativa che contrassegnano tutta un’epoca della storia italiana (la crisi di impotenza e di disfacimento che attanagliava l’Italia nella dittatura fascista). Con spasmodica intensità lo scrittore calabrese percorre un’unica corda, insistendo su una stessa nota acuita progressivamente, per scendere nelle regioni sotterranee dell’anima attraverso il vibrare di sentimenti svolti e avvolti su sé stessi fino alla vertigine. È un ‘hollow man’ (come gli ‘uomini vuoti’ di Eliot), un ‘uomo senza qualità’ (Musil), questo Babel di Alvaro, che brancola solitario in un vuoto metafisico, deprivato com’è di un legame profondo con una razza ed una cultura, con una terra e la sua storia, e dunque con la natura e la verità, con la memoria e la tradizione.