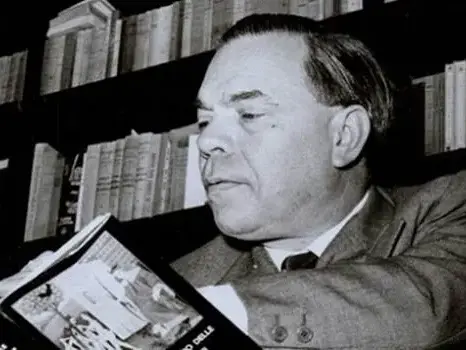Un sussidiario scolastico, compilato con amore dallo scrittore di San Luca, è il primo organico disegno del suo mondo mitico-regionalistico
Tutti gli articoli di Leggendo Alvaro insieme
PHOTO
Non era stato facile. Alla fine del 1919 Alvaro aveva lasciato «Il Resto del Carlino», e Bologna, per trasferirsi a Milano, assunto dal «Corriere della Sera». Ma l’oscuro lavoro redazionale non lo appagava: voleva scrivere, firmare, come invece non gli era concesso. E allora, dopo due anni, ecco un nuovo trasferimento: a «Il Mondo», diretto da Giovanni Amendola, come corrispondente da Parigi. Il prezzo umano da pagare era alto, molto alto: la famiglia lasciata da sola, con il figlio Massimo piccolissimo, mentre lui viveva e lavorava nella capitale europea della cultura. Ci stette per pochi mesi, ma decisivi; e poi a Roma, scrivendo e firmando molto. Il quotidiano era la voce più incisiva della resistenza antifascista; e Alvaro vi contribuì coraggiosamente, con articoli di alto profilo morale che gli costarono anche aggressioni fisiche. Furono anni duri, suggellati dalla chiusura governativa del giornale, nel ’26, quando già Alvaro, che l’anno precedente aveva scritto molto anche sul «Risorgimento» come critico teatrale, aveva chiuso la sua collaborazione.
Nel 1925 esce un suo coraggioso profilo, «Luigi Albertini», datato “ottobre 1924”, un mese prima che il venticinquennale direttore del «Corriere della Sera» fosse costretto ad abbandonare il giornale per imposizione del regime fascista, ormai divenuto dittatoriale. Vi si coglie, in controluce, l'esperienza che ne aveva fatto e la sua renitenza a chiudersi nell'anonimo e spersonalizzante lavoro redazionale, nel quale “i giornalisti sacrificano”, comprimendola, la propria personalità. Al tempo stesso professa la sua ammirazione per una macchina giornalistica che funzionava come le ruote di un perfetto orologio proprio in virtù della fusione delle molteplici competenze umane in unità, che ha consentito ad Albertini di porre il suo giornale “fra i più belli d'Europa”.
Questo non attenua la colpa che il «Corriere» albertiniano ha avuto nell'affermazione del fascismo: Alvaro delinea con esattezza di giudizio, lucidità storica e incrollabile rigore morale la responsabilità che ha avuto nel disegnare un'immagine mitografica e falsa dell'Italia in guerra e nel condurre una lotta spietata contro il socialismo (ha interpretato gli avvenimenti in modo “assolutamente falso e ingannevole”, nell’illusione di poter bloccare a tempo debito la deriva totalitaria), aprendo così le porte a un governo autoritario e ai suoi “delitti di bassa criminalità”. Albertini, però, ha saputo riscattarsi ergendosi contro la dittatura: se fino all’ottobre 1922 “s’inquadra[va] fra le figure più spiccate” del reazionarismo italiano, emblema della resa della borghesia italiana al fascismo, poi ha saputo trovare “nel suo discorso al Senato [del 15 giugno 1924], e nelle colonne del suo giornale, le parole che si dicono ai popoli nei momenti più gravi. E se non fosse che questo, è un vanto che basterebbe alla vita di un giornale e di un uomo”.
Nello stesso anno di "Luigi Albertini” Alvaro si dedica a scrivere un “Libro sussidiario di cultura regionale”, «La Calabria» (1925), concepito in conformità dei “Programmi 11 novembre 1923”, che prevedevano l'identificazione e la salvaguardia dell'etnìa regionale, ed approvato (malgrado la ripulsa alvariana del fascismo) dal Ministero della Pubblica Istruzione nel “Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 giugno 1925”. E l’ha scritto con serietà e cura artigianale: questo sussidiario porta impressa in modo inconfondibile la sua cifra espressiva ed è colmo di dati informativi e statistici, frutto di una documentazione accurata e puntuale.
Apre il libro un prologo, che costituisce la chiave interpretativa di Alvaro sulla storia plurimillenaria della sua terra, della quale dà una sintesi scabra e dolente. La Calabria, che conobbe lo splendore “civilissimo” della Magna Grecia, fu poi per duemila anni “preda di eserciti invasori”. Il popolo era “arroccato a difesa sulle montagne”, mentre la terra, un tempo “prospera e dilettosa”, decadeva rovinosamente, senza che i calabresi, “in lotta perpetua con gli elementi”, abbandonassero “la terra dei padri, resistendo al crollo delle montagne e alla furia dei torrenti”. Dell’antica gloria erano sparite quasi tutte le tracce”, ma non la sua “bellezza amara e solenne”.
In chiusura al sussidiario Alvaro contrappone polemicamente le previsioni dell'“Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali” (secondo la quale la Calabria, “potenzialmente una delle più ricche terre d'Italia”, “sarà, prima o poi, per forza di cose, un paese d'immensa ricchezza industriale ed agraria”) con la realtà amara del presente (e del futuro, aggiungo io), che ne fa “una delle terre meno ricche d'Italia”, salvo che di emigranti, di malaria e di latifondo.
Fra questi due poli si dipana un ciclo stagionale delle opere e dei giorni, mentre si susseguono le immagini del paesaggio calabro, colte nell'avvicendarsi rituale delle colture, che scandiscono il fluire del tempo da ottobre a settembre. All'interno di questa struttura si alterna una serie di rubriche: la delineazione dei grandi calabresi e delle pagine gloriose di cultura regionale (da Pitagora alla Scuola Italica, da Mattia Preti a Telesio, da Campanella a Gravina e a Padula); la Calabria vista dagli stranieri (attraverso un'oculata scelta antologica dalle prose di viaggio di Lear, di Norman Douglas, di Lenormant e di Henry Swinburne); l'aneddotica storica e l'illustrazione geografica; le inserzioni documentali sul presente, supportate anche da dati statistici ed economici; il florilegio di leggende e di canti popolari, di proverbi e di indovinelli, che compongono un quadro antropologico di estremo interesse; e, in ultimo, una serie di tavole cronologiche (il calendario storico nazionale; le opere agricole, le fiere e i mercati periodici del mese).
Trapela, dal libro, una tensione interna che va ben al di là di un mero intento compilativo, divenendo ritrovamento delle radici, riconquista di una identità minacciata dal male della Storia, fascinazione di un passato che si congiunge con il mito. La scrittura di Alvaro può così attingere una vibrazione densa e solenne, come avviene ad esempio in «Paesaggio di Gennaio», stupendamente ritmato dal cromatismo del bianco e del verde: “I pastori sono raccolti attorno alla caldaia che bolle piena di latte. I blocchi di ricotta galleggiano sul siero verde che emana un odore dolce e puro. [...] La gente che arriva dalla marina annunzia d'aver veduto il primo fiore del mandorlo, pallido sulla cima del ramo, di fronte alla montagna coperta di neve”. E ancora: “La conocchia, alta nell'ombra, sembra una testa che si muove infaticabile, con tutti i pensieri e le speranze che il pastore vi incise col suo coltelluzzo. |...| Il bambino s'è già addormentato presso il fuoco dove ha scoperto i mostri e i paesaggi delle favole”.
Sono chiari preannunzi di «Gente in Aspromonte» e della quotidiana lotta drammatica per la vita, che anima tante pagine alvariane e che qui si incide nelle “lunghe file di donne [che] vanno avanti e indietro pei campi a trovar pietre per la muratura: se le caricano sulla testa e le portano fino alla casa nuova”, “come una fila di formiche. Così sono nati i nostri paesi, così crescono, pietra su pietra, fatica su fatica. Da noi tutto nasce da una dura fatica” e dalla lotta contro la natura, quando è ostile, e della Storia. A tutto questo Alvaro contrappone il senso sacro della tradizione, dei gesti che si ripetono immutati da secoli, quasi ad esorcizzare il malessere della civiltà contemporanea e il dissolversi di una concezione millenaria della natura e dell’uomo. Scaturiscono da questa dialettica immagini, nuclei, interi segmenti di scrittura che verranno poi trapiantati ed orchestrati nei racconti di «Gente in Aspromonte» e di altre raccolte di novelle. In «La Calabria» del 1925 il mondo mitico-regionalistico di Alvaro trova per la prima volta un disegno coerente ed organico, proprio nel momento in cui, con «L'uomo nel labirinto» (1926), lo scrittore è più proteso alla conquista di una problematica e di una cifra espressiva di respiro europeo.